Fig.
1 - Christ & Gantenbein, Extension of the Basel Art Museum,
2016. Photo Jean-Pierre Dalbéra/CC BY 2.0

Fig.
2 - Christ & Gantenbein, Extension of the Zurich Landesmuseum,
2016. Photo Adrian Michael/GNU FDL

Fig.
3 - Visitors at the Mona Lisa, Louvre, Paris.

Fig.
4 - From the web: hashtag #monalisa.

Fig.
5 - Christo, Floating Piers, Lake Iseo, 2016. Foto NewtonCourt/CC BY-SA
4.0

Fig.
6 - From the web: hashtag #floatingpiers.
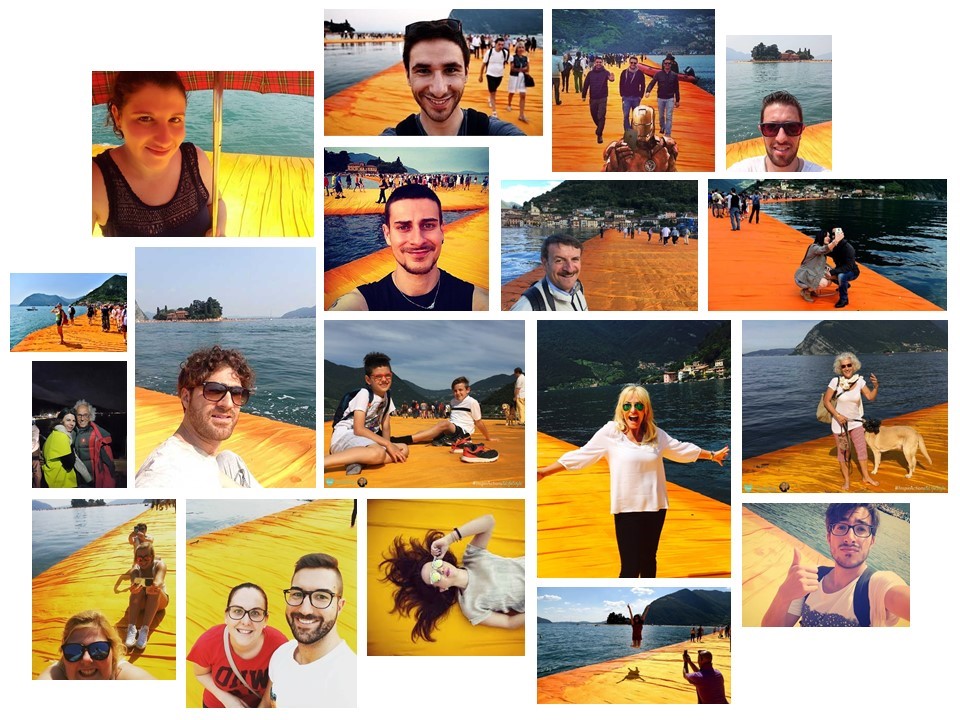
Fig.
7 - Marina Abramović, The Artist is Present, MoMA, New York, 2010.
Photo Andrew Russeth/CC BY-SA 2.0

Fig.
8 - Extension of the Zurich Landesmuseum. Photo Photones/CC BY-SA 4.0

Fig.
9 - Basel Art Museum, the extension and in the background the original
building by Christ and Bonatz, 1936. Photo Andreas Schwarzkopf/CC BY-SA
3.0

Fig.
10 - Basel Art Museum, second floor plan.
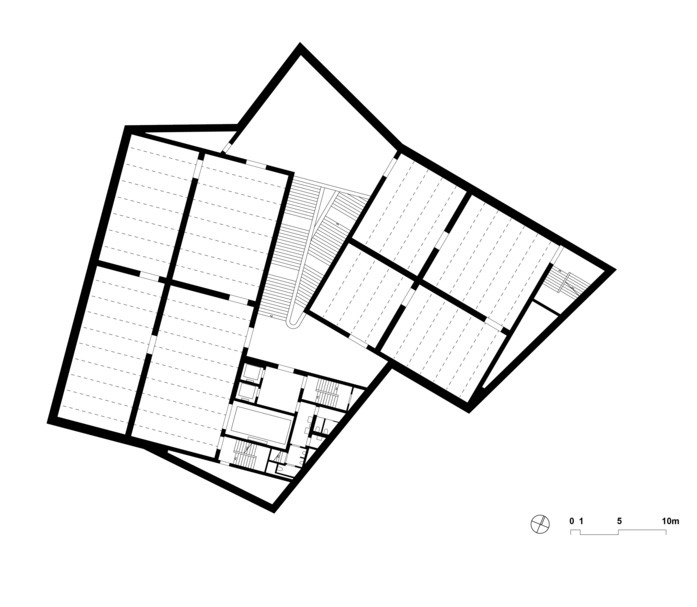
Fig.
11 - Basel Art Museum, main stairway. Photo Jean-Pierre
Dalbéra/CC BY 2.0
