Fig.
1 - Adolf Franz Karl Viktor Maria Loos.

Fig.
2 - Frontespizio della rivista redatta da Adolf Loos DAS ANDERE, II,
1903.
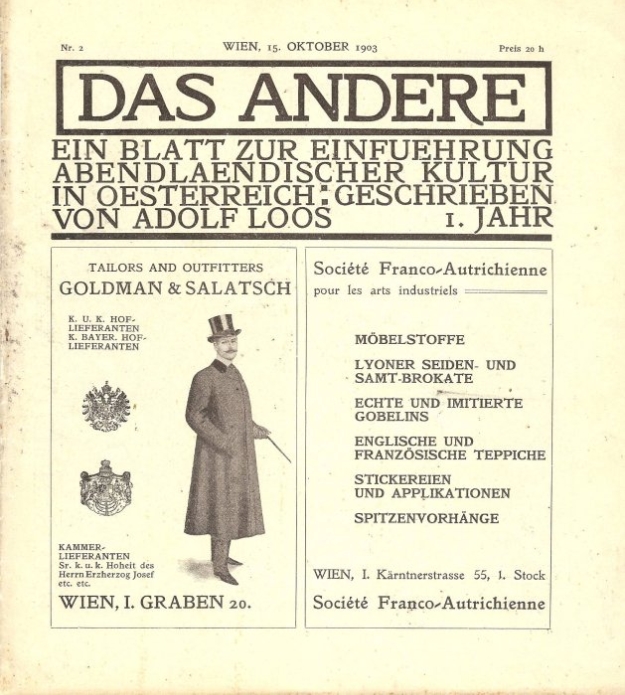
Fig.
3 - Adolf Loos con Karl Kraus e Herwarth Waldenl, 1909.

Fig.
4 - Adolf Loos tende l’orecchio, Dessau, 1931.

Fig.
5 - Adolf Loos con la seconda moglie, l’attrice Elsie
Altmann, 1921

Fig.
6 - Adolf Loos in America, 1895.

Fig.
7 - Prima edizione di Parole nel vuoto, pubblicata a Parigi e Zurigo
nel 1921.
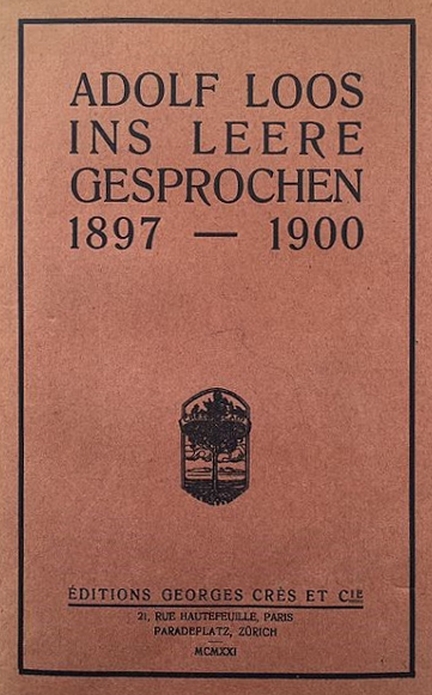
Fig.
8 - Inaugurazione del Café Museum. Adolf Loos in piedi a
destra, 19 aprile 1899.

Fig.
9 - Soggiorno di casa Müller, Praga 1930.

Fig.
10 - Adolf Loos con Claire Back, il giorno del loro matrimonio, luglio
1929.

Fig.
11 - Adolf Loos con Claire Back e Kiki, la loro cagnolina giapponese,
1930.

Fig.
12 - Ornament und Verbrechn, locandina della conferenza pubblica del 12
marzo 1909.

Fig.
13 - Adolf Loos con Lina Loos Obertimpfler, Peter Altemberg e Heinz
Lang, 1904.
