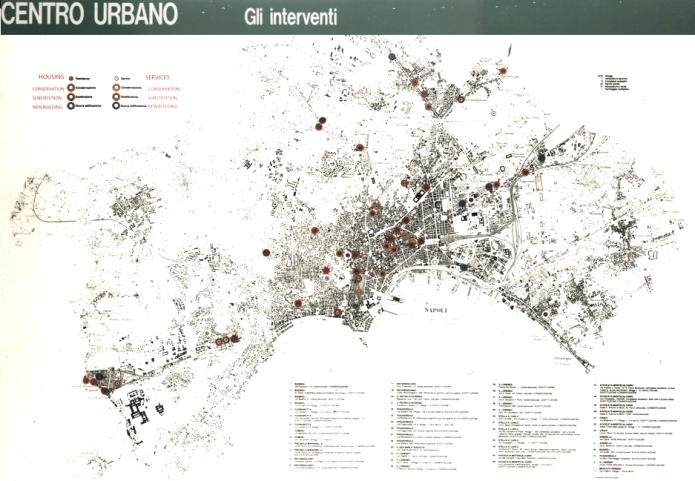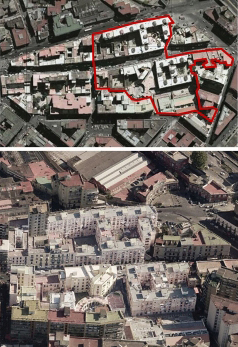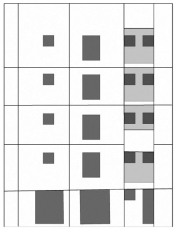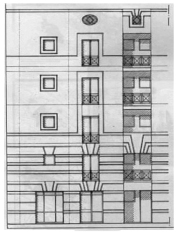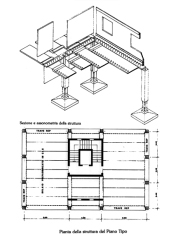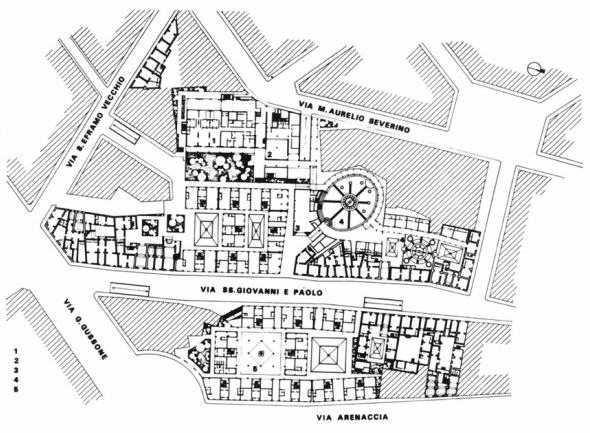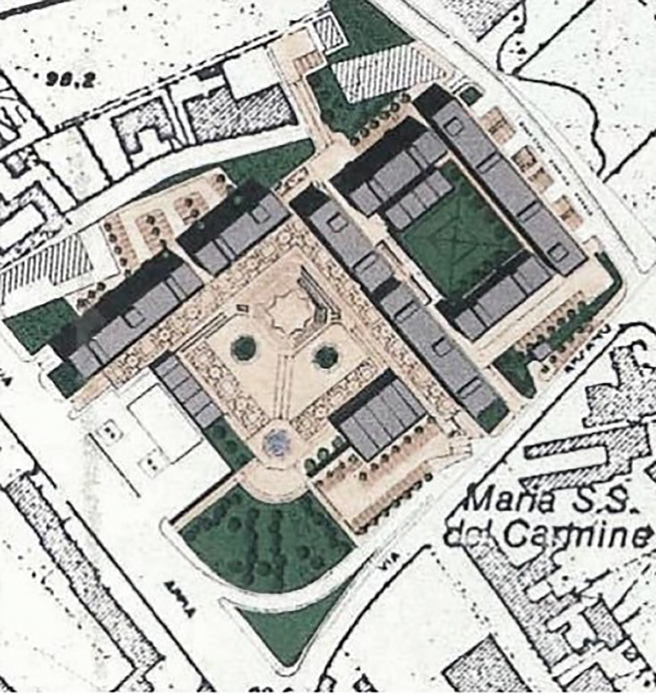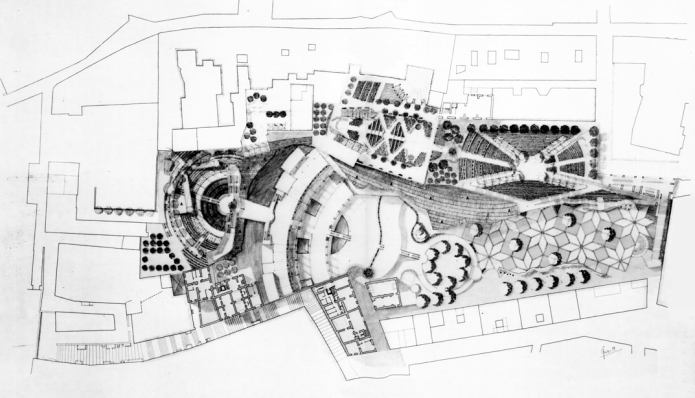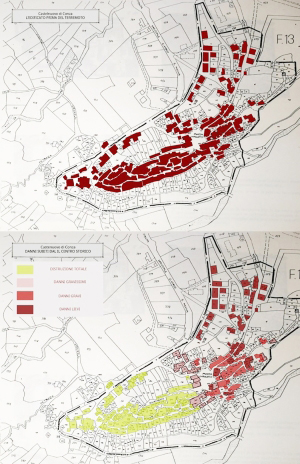Due lezioni da un terremoto
1 - Città estrema
2 - Il Borgo
Lucio Valerio Barbera
Fig.
1 - I due epicentri del Terremoto dell’Irpinia: nel cerchio
nero l’epicentro sismico, i comuni del Cratere e del suo
immediato intorno. Nel cerchio rosso il cosiddetto epicentro sociale,
costituito dalla città metropolitana di Napoli, scossa sue
strutture edilizie, ma soprattutto sociali.

Fig.
2 - I progetti inclusi nel Comparto Centro Urbano nel Piano di
ricostruzione e Riqualificazione di Napoli. Il comparto Centro Urbano
includeva la città storica – detta Centro antico
– gli insediamenti periurbani e la prima cintura moderna.
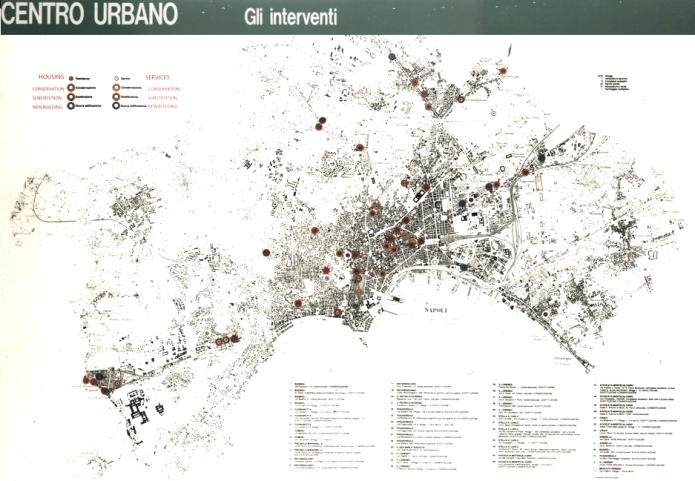
Fig.
3 - SS. Giovanni e Paolo Piano di recupero e principali interventi
edilizi. Dall’alto:
Il tessuto; Il patrimonio edilizio; I principali interventi; I
principali interventi realizzati.

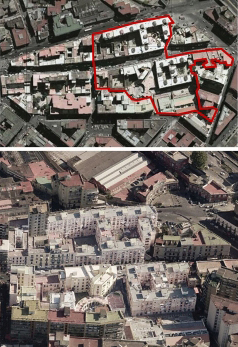
Fig.
5.1 - SS Giovanni e Paolo; piani terra; principali servizi: asilo nido,
ufficio postale, uffici circoscrizione, mercato coperto, piazza
pedonale.
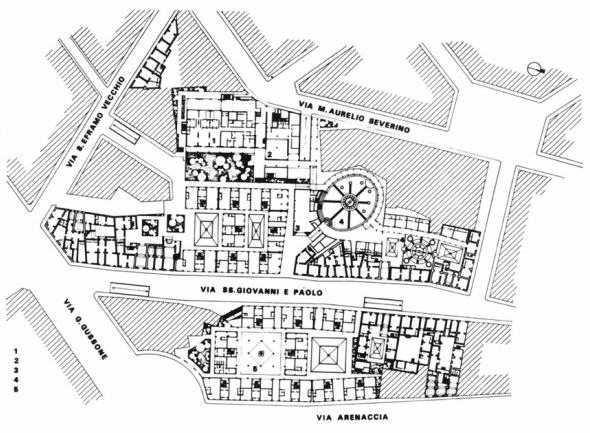
Fig.
5.2 - Viste d’insieme e di dettaglio
dell’inserimento dei nuovi edifici nell’ambiente
urbano a 30 anni dalla realizzazione.


Fig.
6 - Due interventi nel tessuto urbano di Secondigliano. A - Complesso
residenziale per 200 alloggi al Quadrivio di Arzano. B - Centro
benessere: piscina, palestra, giardini e campi sportivi
all’aperto.

Fig.
7 - Planimetria generale; Foto aerea;
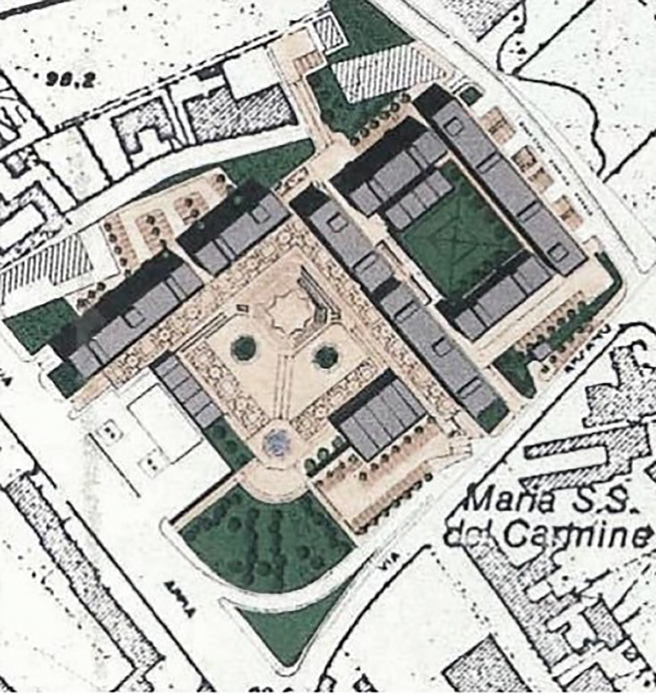

Fig.
7.1 - Prospettiva di progetto: la corte principale; Vista laterale del
complesso.


Fig.
8 - Foto aerea del Centro; Il Centro nel tessuto edilizio; Il fronte su
Corso Secondigliano; Interno della palestra.

Fig.
9 - In rosso il perimetro del Centro storico di Napoli (Centro Antico e
gli ampliamenti barocchi). In giallo l’area del Piano di
Recupero di Via Avellino a Tarsia.

Fig.
9.1 - Il sistema delle cave antiche.

Fig.
9.2 - Una tavola del Piano di Recupero: (titolo di proprietà
dei fabbricati).

Fig.
10 - Lo stato dell’area di intervento prima della
realizzazione del Piano di Recupero e del progetto del Parco
Ventaglieri.


Fig.
10.1 - Planimetria generale del progetto del Parco Ventaglieri;
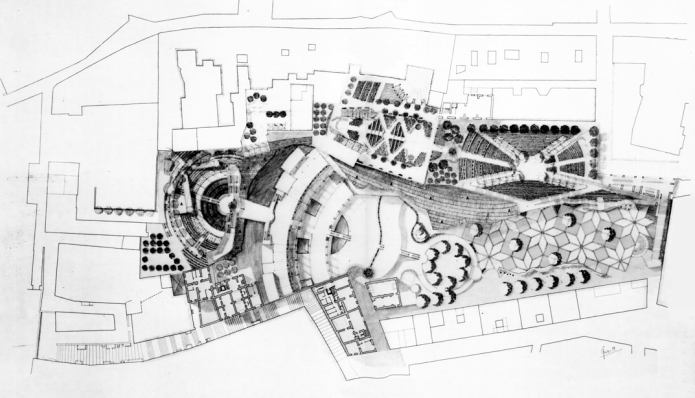
Fig.
10.2 - Vista generale del progetto realizzato del Parco Ventaglieri. Si
notano: i volumi e i terrazzi a gradoni del complesso scolastico; i
giardini alle varie quote; il sistema di scale e rampe che collegano i
diversi livelli.

Fig.
11 - Viste del Parco Ventaglieri nel tessuto urbano.

Fig.
12 - Le funzioni oggi attive nel – e attorno al –
Parco Ventaglieri; Animazione culturale e ricreativa nel Parco
Ventaglieri.

Fig.
13 - Una stampa, XVII sec: il paese raccolto attorno al castello e alla
chiesa; Stemma di Castelnuovo di Conza.


Fig.
14 - Foto dopo il sisma. La parte più antica del paese fu
rasa al suolo; Il profilo del paese da Sud in una foto prima del
terremoto; Il profilo attuale del paese da Sud; Il profilo del Paese da
Nord in una foto prima del terremoto; Il profilo attuale del paese da
Nord.


Fig.
15 - Le parentesi orizzontali in rosso corrispondono alla stessa
porzione di crinale dove insisteva la parte più antica del
paese.

Fig.
16 - Il “paese” prima del terremoto; I danni subiti
dal terremoto; Lo stato attuale del “Centro
Storico” dopo la ricostruzione.
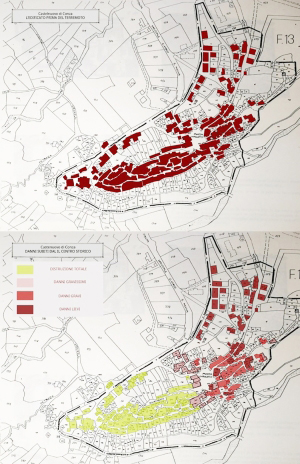

Fig.
17 - Castelnuovo Conza oggi; L’arrivo al paese da Nord; sullo
sfondo, a destra, la collinetta boscata ove sorgeva la parte
più antica del centro. Il paese ha “cambiato
verso”. Da tipico insediamento di crinale è ormai
un paese poggiato su lenti gradoni paralleli. Ciò che resta
del centro antico fa da fondale unificante dei nuovi allineamenti. Ma
il nuovo abitato non si ferma qui. Guarda figura successiva.

Fig.
17.1 - Castelnuovo Conza oggi.

Fig.
18 - La parte restante dell’antico paese, ora Centro Storico;
Una tipica scalinata del Centro storico; Un vico.

Fig.
18.1 - La piazza, chiamata Lu Chianedh’ restaurata dopo il
terremoto, riprende vita nelle ricorrenze religiose.

1 - Città estrema
Il programma di Ricostruzione del Centro Urbano di Napoli
1981 - 1991
All’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, a seguito del
terremoto del 23 novembre 1980, che scosse gran parte della Campania ed
ebbe l’epicentro nell’Irpinia, fui chiamato ad assumere la
responsabilità di Coordinatore della progettazione
architettonica e urbana di un complesso programma di ricostruzione e
riqualificazione edilizia e funzionale in favore del Centro Urbano di
Napoli, da attuarsi attraverso più di 50 progetti di scala e
complessità anche molto diverse tra loro. I luoghi e i manufatti
su cui intervenire erano stati scelti dal Commissariato di Governo per
la ricostruzione, nel corpo vivo del Centro antico e della prima
espansione urbana moderna, il cui insieme costituisce l’organismo
centrale - il Centro urbano, appunto - della attuale metropoli di
Napoli. Città, questa, che per la profonda stratificazione
storica delle sue strutture edilizie, per la complessità e il
diffuso disagio del suo corpo sociale e per l’altissimo livello
della sua cultura - che convive con la presente complessità
urbana e umana - può essere considerata “Città
estrema” nel quadro delle grandi città del mondo
occidentale e, in particolare, del Mediterraneo europeo.
Il programma che mi fu affidato faceva parte di un ben più
vasto programma di riqualificazione della intera città di
Napoli. Nei fatti, quell’evento aveva avuto due epicentri: uno
sismico nell’area di alcuni paesi dell’Irpinia (Fig.1,
cerchio nero) con distruzioni e lutti ingentissimi (quasi tremila
morti) e uno sociale nell’area di Napoli (Fig.1, cerchio rosso)
che ebbe poche vittime rispetto a quelle dell’epicentro (circa
sessanta morti per il crollo di un edificio residenziale moderno), ma
fu scossa e danneggiata in molte sue strutture edilizie e sociali. Il
programma completo per la ricostruzione a Napoli prevedeva la
realizzazione di ventimila alloggi, andava attuato realizzando il
cosiddetto Piano delle Periferie, costituito da dodici piani integrati
di nuova edilizia e recupero urbano. Ma il Piano delle Periferie, per
sua natura, non dava alcuna risposta alla domanda di interventi
pubblici nel centro della città. Per questo fu data vita allo
speciale Comparto Centro Urbano che fu affidato al Consorzio Edina, del
gruppo EFIM che a sua volta mi chiese di assumerne la
responsabilità come Coordinatore della progettazione
architettonica e urbana.
I più di cinquanta progetti del programma di intervento del
Comparto Centro Urbano (Fig. 2), di cui accettai la
responsabilità progettuale, comprendevano due classi funzionali
- residenze e servizi urbani - e tre tipi di intervento edilizio:
restauro, sostituzione, nuova edificazione. Incrociando le due classi
funzionali e i tre tipi di intervento i progetti furono raggruppati in
sei categorie. Ma ciascuno di essi era un unicum progettuale sia per i
suoi caratteri storici, sia per i caratteri, sempre specialissimi, del
contesto Per affrontare in modo credibile un compito così
complesso costituii un gruppo di lavoro interdisciplinare che includeva
storici dell’architettura e della città, progettisti
strutturali e impiantistici, urbanisti, paesaggisti e architetti, fra
cui Arnaldo Bruschi, Antonio Michetti, Gianfranco Caniggia, inseriti
nel Comitato Tecnico Scientifico da me voluto; Vittoria Calzolari,
Alberto Gatti, Salvatore Bisogni, Antonio Lavaggi tra i progettisti.
Durante il lavoro di coordinamento e progettazione fui assistito,
naturalmente, dall’ufficio tecnico dell’Edina oltre che
dagli allora giovani architetti, Corrado Giannini e Silvana Manco, del
mio gruppo professionale, la ProgReS, di Roma. Il Commissariato di
Governo per la Ricostruzione a sua volta costituì un gruppo di
tecnici e consulenti sotto la guida di Vezio De Lucia; con il compito
di garantire il rispetto delle linee di indirizzo della ricostruzione
in un continuo lavoro di dialettica e collaborazione con i progettisti
dei Consorzi concessionari. Noi avemmo la fortuna di essere seguiti,
per conto del Commissariato di Governo, da un allora giovane architetto
di grandissimo valore, Giancarlo Ferulano, che non soltanto fu
determinante per il rispetto degli obbiettivi della ricostruzione, ma
anche per la verifica delle linee progettuali di ogni intervento in
funzione degli obbiettivi sociali e culturali del programma.
Proprio perché non mi nascondo che sarebbe stato
metodologicamente interessante che nei quarant’anni trascorsi da
quell’impresa io l’avessi ripercorsa criticamente, come non ho fatto,
colgo l’occasione che mi viene data da FAM - che ringrazio
sinceramente - per tentare di mettere fuoco almeno uno dei problemi che
subito emersero nel nostro lavoro e che divenne ben presto dominante.
Si tratta del problema del rapporto tra le attese del
“committente sociale”, cioè dei futuri utenti - e
gli obbiettivi e le aspirazioni dei progettisti. Napoli è una
città di forte carattere identitario, nella quale si ha
l’impressione che viva quasi intatto l’amalgama sociale
della città antica accanto a una affermata e fiorente
società borghese. Ma mentre questa, pur essendo erede
dell’aristocrazia della cultura napoletana, ha naturalmente
mutuato gran parte dei modi “transnazionali” che
caratterizzano le società urbane in qualunque altro punto del
nostro pianeta, quella mantiene quasi intatti tutti i suoi
“pro” - creatività e urbanità - e i suoi ben
noti “contro”, che emergono con i caratteri di un
resistente arcaismo, distorto dalla modernità. In questo quadro
troppo schematico - lo so e me ne scuso - tuttavia, ciò che
sorprende e affascina soprattutto un romano come me, figlio di
immigrati - come la maggior parte dei miei concittadini - è il
rapporto naturale e sorprendente tra borghesi e popolani, qui a Napoli;
un rapporto nel quale ciascuno, mantenendo la propria identità
sociale, naturalmente sa intendere e parlare la lingua dell’altro
come si trattasse di una delle tonalità nelle quali è
composto ed eseguito, giorno per giorno, un vivo monumento musicale
alla cui unità ognuno sa di partecipare paritariamente. In
questa complessità, tuttavia, il nostro lavoro progettuale,
indirizzato a operare nelle pieghe e nelle plaghe più disagiate
della città, per statuto si rivolgeva proprio al
“committente sociale” più antico e identitario tra
quelli conviventi nella città. Per nostra fortuna, e per la
fortuna del lavoro, il nostro impegno a Napoli durò quasi un
decennio. Ci fu offerta, dunque, la possibilità di vivere la
città e, soprattutto, i luoghi dei nostri interventi,
direttamente e a lungo. Ci parve, dunque, di comprendere qualcosa.
Qualcosa di importante del rapporto tra il nostro “committente
sociale” e l’architettura del proprio spazio di vita; ma
per timore di non essere in grado di farlo con mie parole, affido la
definizione di ciò che mi sembrò di aver capito, alle
parole - ormai antiche nel “moderno” - di Walter Benjamin,
strappate alle prime pagine del suo libro su Napoli, sulla sua
società, la sua architettura:
«L’architettura è porosa quanto questa pietra [intende la pietra in cui è scavato il sistema delle grotte e delle cave antiche di Napoli]. Costruzione
e azione si compenetrano in cortili, arcate, scale. Ovunque viene
mantenuto dello spazio idoneo a diventare teatro di nuove, impreviste
circostanze. Si evita ciò che è definitivo, formato.
Nessuna situazione appare come essa è, pensata per sempre,
nessuna forma dichiara il suo ‘così e non
diversamente’. È così che qui si sviluppa
l’architettura come sintesi della ritmica comunitaria [...] il
nucleo dell’architettura urbana [...] è rappresentato
dall’isolato, tenuto insieme agli angoli, come fossero grappe di
ferro, dai dipinti murali rappresentanti la Madonna».
Si evita ciò che è definitivo, formato.
Nessuna situazione appare come essa è, pensata per sempre,
nessuna forma dichiara il suo ‘così e non
diversamente’. Ecco: queste due frasi che, lette da
un impegnato intellettuale dei nostri tempi, possono far pensare a un
Benjamin che indulga in un’immagine convenzionale della nostra
Città estrema, mi colpirono quando le lessi: confermavano quanto
avevo appreso non soltanto osservando la realtà dei luoghi dove
avevamo operato a Napoli, ma vivendo le difficoltà dei nostri
primi progetti. Quelle brevi frasi confermavano, in fondo, che le
scelte che facemmo dopo i primi momenti di mal orientate certezze erano
almeno un tentativo di avvicinarsi, anche se di poco, alla
realtà delle attese del nostro “committente sociale”
e, soprattutto alla vitalità del suo irrinunciabile modo di
continuamente rimodellare il proprio ambiente secondo la propria
identità culturale.
Qui di seguito, quindi ho scelto di presentare quattro progetti che,
tra gli altri, mi pare rappresentino con maggiore chiarezza questo
nostro tentativo. Il primo riguarda il Piano di Recupero e la
ricostruzione edilizia di un insediamento storico inglobato da tre
secoli nella città di Napoli. In questo caso la ricostituzione
del tessuto urbano degradato per mezzo di nuovi edifici residenziali e
alcuni servizi aperti al pubblico, fu affrontata confermando
“l’isolato a corte” come tipologia urbana più
fedele alle aspettative del “committente sociale” e
utilizzando un linguaggio architettonico basato sulla mimesi dei colori
e delle movenze dell’edilizia urbana ottocentesca,
l’ultima, io credo, che a Napoli realizzò con naturalezza,
il passaggio dalla città barocca alla città del
positivismo e della prima modernità. Il secondo e il terzo
progetto fanno parte di un’azione di riqualificazione “per
punti” di un quartiere di fortissima identità popolare e
storica. Il quarto progetto riguarda l’intervento architettonico
- ma meglio sarebbe dire “tettonico” - che fu realizzato
nel cuore di un altro Piano di Recupero di un quartiere antico. La
rapida descrizione dei quattro progetti, a parte ogni giudizio di
valore - che può essere negativo per molti aspetti - credo possa
testimoniare abbastanza chiaramente sia il nostro tentativo di
interpretare le esigenze del “committente sociale” sia la
sua capacità di appropriarsi naturalmente, ma ineluttabilmente,
d’ogni progetto con pochi tocchi identitari, immettendolo
così nella realtà della vita.
Il Piano di Recupero del quartiere di SS. Giovanni e Paolo.
Alcuni interventi furono destinati a riabilitare interi nuclei
storici di quartieri urbani della città centrale. Uno di tali
nuclei, quasi un quartiere in sé stesso, in località S.
Carlo all’Arena, ha il nome di “SS. Giovanni e
Paolo”. Si tratta di un antico insediamento situato fuori delle
mura della città antica, inglobato nell’area urbana a
partire dalla metà diciottesimo secolo quando, a suo ridosso,
per volontà del re Carlo di Borbone, l’architetto
Ferdinando Fuga realizzò la gigantesca mole del Real Albergo dei
Poveri. Una parte dell’antico insediamento, già
semiabbandonata, era stata demolita subito dopo il terremoto. Grandi
vuoti s’erano aperti nel tessuto antico. Nel resto
dell’edilizia storica del nucleo convivevano tipologie molto
antiche e rovinate, a corte aperta e bassa densità, assieme ad
edifici ottocenteschi di più densa consistenza urbana. Edilizia
moderna molto alta e di cattiva qualità premeva al loro intorno.
Il problema principale, in questo caso, fu quello di ricostituire
l’unità ambientale e funzionale del quartiere così
che la popolazione potesse naturalmente percepire i nuovi edifici ed
usarli come appartenenti alla tradizione dei luoghi, nonostante fossero
evidentemente realizzati con sistemi costruttivi industrializzati ed
economici. (Figg. 3-4-5)
Il sistema costruttivo che fu scelto è di per sé molto
vicino, forse il più vicino, ai modi tradizionali di realizzare
l’involucro edilizio, in quanto riporta la finestra al concetto
di semplice bucatura, di varie dimensioni, aperta in una parete
caratterizzata da una serie ripetuta di vuoti piuttosto piccoli
rispetto al prevalere della superficie piena. Tuttavia le applicazioni
prefabbricate di tale concezione, che hanno generato un ben noto
sistema – il pannello finestra – in generale danno luogo ad
immagini che sono tra le più alienanti dell’edilizia
moderna: ininterrotte sequenze di fori quadrati senza alcun elemento di
qualificazione, pareti alveari ossessive, impossibili da integrare in
alcun paesaggio urbano moderno, tradizionale o storico. Ma a ben
guardare, l’immagine più familiare e gradita che ci viene
incontro dalle pareti che si allineano lungo le strade del centro di
una qualsiasi nostra città storica, altro non è che il
frutto di una semplice articolazione simbolica e costruttiva - dunque
architettonica - di una parete muraria in cui si aprono ordinatamente
– cioè monotonamente - bucature tendenzialmente uguali e
relativamente piccole. In questo quadro, tenendo conto
dell’obiettivo di inserire senza strappi la nuova edilizia
nell’ambiente esistente, seguimmo appunto quella strada
tradizionale e ben sperimentata, incidendo la superficie dei pannelli
prefabbricati in modo da comporre sulle facciate, una gerarchia di
simboli architettonici chiara ed efficace perché naturalmente
comprensibile (Figg. 4).
Due interventi nel tessuto urbano di Secondigliano
Il programma di riqualificazione affidato al Comparto “Centro
Urbano” di cui sono stato progettualmente responsabile, oltre ad
alcuni complessi interventi coordinati dallo strumento urbanistico del
Piano di Recupero – di cui abbiamo visto un esempio nelle pagine
precedenti – comprendeva una moltitudine di interventi puntuali,
per lo più monofunzionali – residenza, specifici servizi,
zone verdi. Essi furono opportunamente inseriti in alcuni vuoti dei
tessuti preesistenti con il duplice obbiettivo di rispondere alla
urgente domanda di abitazioni popolari e dotare l’ambiente urbano
di attrezzature a servizio della popolazione. In questo quadro credo
sia utile presentare due interventi puntuali, di dimensione e funzione
diversa – un complesso residenziale a basso costo e un centro di
servizi per lo sport e il benessere – ambedue collocati a non
grande distanza l’uno dall’altro sull’asse di Corso
Secondigliano. (Fig. 6) Nella loro diversità dimensionale,
funzionale e architettonica nonché nella loro specificità
gestionale, i due interventi, tuttavia, furono concepiti come parti di
un contributo unitario – ancorché molto parziale –
alla riabilitazione di una zona critica della cintura di Napoli. Corso
Secondigliano è il nome che la Via Appia prende attraversando
l’antico insediamento periurbano che costituisce una complessa, a
volte difficile realtà sociale.
- Il complesso residenziale sito nel cosiddetto Quadrivio di Arzano -
circa 200 alloggi - è diventato noto per alcune recenti serie
televisive, essendo stato citato in libri e film che indagano la
complessità sociale di quel territorio. L’intervento non
fu mai veramente finito, perché gli alloggi, ancor prima del
loro completamento, furono occupati da una moltitudine popolare che si
stabilì in essi senza rispettare le regole di assegnazione.
Tuttavia, da allora è stato abitato e adempie sostanzialmente
alle sue funzioni. Il complesso è organizzato attorno a una
corte principale in forma di piazza aperta sul Quadrivio di Arzano. Il
sistema costruttivo è lo stesso adoperato nell’esempio
precedente, ma finito con colori chiari e meno contrastati. (Figg.7).
- Il Centro di servizi per lo sport e il benessere, affacciato su Corso Secondigliano, include
una piscina da allenamento, una palestra, una palestra per arti
marziali, campi sportivi e aree verdi. Adoperando una dizione
anglosassone molto diffusa, questo è un tipico progetto infill
che attraversa letteralmente il corpo del tessuto urbano utilizzando
una esigua sequenza di spazi liberi, stretti fra gli edifici. Composto
di corpi di fabbrica e piccole aree pubbliche attrezzate, collega la
strada principale – Corso Secondigliano - con l’interno del
quartiere, senza soluzione di continuità. Il complesso pare
funzionare bene e sembra essere stato molto ben accolto dalla
popolazione locale che ne ha fatto un centro di incontro e ricreazione
per l’educazione fisica individuale e collettiva (Figg.8).
Piano di Recupero di Via Avellino a Tarsia e Parco dei Ventaglieri
Un altro Piano di Recupero di una zona complessa del Centro Storico
di Napoli riguardò il crinale su cui corre Via Avellino a Tarsia
e le sue adiacenze sino alla zona Ventaglieri (Figg.9). Elemento
fondamentale del Piano di Recupero fu la bonifica e il riuso di una
vasta area interclusa tra gli spalti del crinale di Tarsia e Vico Lepri
ai Ventaglieri, interessata anche da un vasto sistema di cave. In tale
area dopo il terremoto era stato necessario demolire un degradato e
informe tessuto edilizio in gran parte già abbandonato. Nel
vuoto creatosi realizzammo un importante parco urbano che comprende una
scuola dell’obbligo, giardini pubblici su diversi livelli ed un
sistema di ascensori e scale che collegano le due parti
dell’area, quella inferiore, attorno a Vico Lepri ai Ventaglieri,
e quella superiore attorno a Via Avellino a Tarsia. (Figg.10-11) Il Parco dei Ventaglieri,
come viene chiamato oggi il progetto realizzato, sembra aver avuto un
notevole successo sociale: nei suoi spazi si svolgono spontanee e
pubbliche funzioni collettive, con attiva partecipazione da parte degli
abitanti. (Figg.12).
Il progetto del Parco è concepito per favorire
l’integrazione fra le funzioni scolastiche e gli spazi pubblici.
Una parte delle coperture terrazzate della scuola sono anche di uso
pubblico, mentre la scuola stessa può accedere ad alcuni spazi
del Parco. I giardini sono collegati da un sistema di percorsi che
introduce, accanto agli “horti conclusi” e alle zone di
sosta, l’invito all’esplorazione, cioè a vivere i
luoghi anche in modo riservato e soggettivo. Il Parco è a
servizio di un vasto ambito urbano e sociale; ma un suo effetto
particolarmente positivo è stato quello di aver indirettamente
riqualificato la vita quotidiana di chi vive negli edifici
dell’immediato intorno, oggi affacciati su uno spazio pubblico
che, a più di trent’anni dalla sua realizzazione, sembra
gestito con sufficiente cura e usato con raro interesse.
Ludovico Quaroni, al cui magistero mi sono formato, ci insegnava che
i progetti realizzati sono come figli che diventano adulti: non
dobbiamo sperare che si mantengano inalterati, come li abbiamo
disegnati. Al contrario, dobbiamo augurare loro di attrarre interessi
diversi dal nostro e di sapersi adattare alle esigenze che, se amati,
saranno chiamati ad esaudire. Così, non mi rattrista davvero che
un campo di calcetto abbia coperto una parte del bel pavimento a grandi
stelle che avevo disegnato con cura nella piazza bassa; sono lieto,
invece, che quello spazio abbia trovato una funzione - da me non
prevista - che ha aumentato la sua capacità di attrazione. E
conta ancora di più che la gamma degli spazi di cui è
composto questo “arduo” Parco abbia sollecitato la
fondazione di una istituzione “partecipata”, il Parco
Sociale Ventaglieri, di cui qui di seguito trascrivo il link del sito,
che parla di questo progetto con più verità di quanta
possa esprimerne io:http://www.parcosocialeventaglieri.it/pagine/parco.htm
2 - Il Borgo
Il programma di Ricostruzione del Comune di Castelnuovo di Conza 1981 - 1991
Negli stessi anni in cui ero impegnato nella riqualificazione del
Centro Urbano di Napoli, fui chiamato a interessarmi, con il mio gruppo
romano di architetti, della ricostruzione del Comune di Castelnuovo di
Conza, il più vicino all’epicentro del terremoto
dell’Irpinia nel vero e proprio Cratere sismico
(Fig. 13). Il quadro istituzionale del lavoro era molto diverso da
quello nel quale operavo a Napoli: questa volta capofila del lavoro di
progettazione era una importante società di ingegneria, la
Technital di Verona - che collaborò con i tecnici della
Protezione Civile e del Commissariato di Governo per la Ricostruzione
specialmente per quanto riguardava gli aspetti prettamente sismici e di
sicurezza. Il mio gruppo di lavoro, che aveva anch’esso forma di
società di progettazione - la ProgReS (acronimo di Progetti
Ricerche e Studi) - aveva agito per anni come costante riferimento
della società capofila per la progettazione di architettura e
urbanistica in Italia e all’estero. Come giù detto, nella
società ProgReS condividevo le mie responsabilità di
progettazione con gli allora giovani Corrado Giannini e Silvana Manco.
Nel caso di Castelnuovo di Conza fu Corrado Giannini a seguire il
lavoro con autonomia crescente via via che si passò dalla
impostazione alla progettazione alla realizzazione. Corrado Giannini ed
io ci conoscevamo da decenni. Lo avevo incontrato nei primi anni
sessanta del secolo scorso, quando egli, assieme a Francesco Cellini,
Maurizio Cagnoni, Domenico Cecchini era tra i migliori studenti degli
ultimi anni della facoltà di architettura della Sapienza di
Roma, dove io svolgevo già i miei primi incarichi di docente.
Negli anni della ricostruzione di Castelnuovo di Conza, egli fu
coadiuvato con grande intelligenza da Mario Andreanò, che
diresse lo studio appositamente aperto dalla Technital a Battipaglia;
per alcune idee preliminari chiamammo a collaborare con noi Francesco
Cellini, come spesso avevamo fatto negli anni precedenti in altri
lavori. Il Comune di Castelnuovo di Conza, pur appartenendo alla
provincia di Salerno, è disteso su un crinale delle propaggini
nord-occidentali dell’Appennino lucano, a 650 metri
nell’alta valle del fiume Sele. Il suo abitato principale - il
“paese” - aveva subito una devastante distruzione la sera
del 23 novembre 1980, quando il terremoto lo colpì duramente. La
parte più antica dell’abitato fu completamente distrutta
(Figg.15) e il numero di morti - 85 su circa mille abitanti - non fu
maggiore soltanto perché la scossa avvenne alle 19:30, di
domenica. La gente era ancora in piazza prima di cena; il paese viveva
come una comunità coesa, le strade erano gli spazi della vita
collettiva. La parte più alta, antica e ripida del borgo fu rasa
al suolo. La piazza situata nel punto centrale del crinale rimase
monca. Tutti gli edifici a ponente furono spazzati via dal sisma,
quelli a levante restarono in piedi, ma gravemente danneggiati.
(Figg.16). Anche se il tempo aveva già fatto sparire la torre
che spicca nelle stampe antiche e nello stemma civico (Figg.14), fino
alla sera del terremoto l’abitato era tutto raccolto attorno al
vertice più alto e antico del crinale, dove emergevano ancora le
restanti murature del castello e la piccola chiesa patronale (Figg.17).
La forma del paese e l’identità sociale ancora
coincidevano: ma quella sera la figura identitaria del paese si
dissolse. L’esame geologico che precedette la progettazione
scartò l’idea di ricostruire la parte
dell’insediamento antico rasa al suolo dal terremoto: in quella
zona il sottosuolo era composto da un banco di grandi rocce intrusive
frammentate, tali cioè da entrare in devastante risonanza con
l’onda sismica, come era appunto avvenuto. Il programma di
progettazione prese la forma di un Piano Regolatore Generale molto
dettagliato, che possiamo considerare formato da due parti: ciò
che rimaneva del Centro Storico fu oggetto di un meticoloso studio come
in un vero e proprio Piano di Recupero. Lo studio stabilì,
edificio per edificio, i caratteri tecnici e architettonici della
ricostruzione e del ripristino edilizio antisismico, funzionale ed
estetico; esso definì nel dettaglio anche le caratteristiche del
recupero degli spazi pubblici, vicoli, strade e piazze
dell’antico centro. Per le nuove costruzioni, necessarie per
sostituire l’edilizia distrutta dal sisma, il Piano agì
come vero e proprio Piano Particolareggiato Planivolumetrico; oltre a
scegliere le aree di intervento, esso disegnò nel dettaglio la
rete degli spazi pubblici e stabilì i caratteri tipologici,
volumetrici e architettonici degli edifici della nuova espansione. Tra
gli edifici progettati ex novo spicca la nuova chiesa parrocchiale,
posta nel principale snodo della nuova espansione, dove risiede, ormai,
la maggior parte della popolazione. Il Piano Regolatore incluse un
piccolo insediamento residenziale che trovammo già realizzato.
Esso era il frutto di un’iniziativa di Indro Montanelli; era
stato rapidamente messo in opera, subito dopo il sisma, con un sistema
di prefabbricazione in cemento armato. Ma l’attuale insediamento
di Castelnuovo di Conza comprende anche un altro quartiere a sé
stante, non incluso nel Piano Regolatore perché costituito dalle
abitazioni provvisorie prefabbricate in legno, che avrebbero dovuto
essere smontate e portate via dopo la ricostruzione. In realtà,
una volta assegnate, quelle abitazioni non furono più restituite
ed entrarono a far parte, stabilmente, del patrimonio in uso di quasi
ogni famiglia di Castelnuovo. Esse erano state realizzate da una famosa
ditta dell’Alto Adige. Solide e ben costruite, di non spiacevole
aspetto - ancorché fuori luogo nell’Appennino lucano -
ampliano ancora di più la superficie occupata
dall’insediamento moderno, comunque molto maggiore di quella
dell’antico paese se non altro per ragioni di adeguamento agli
“standards urbanistici” moderni. (Fig.18)
Il Piano Regolatore prevedeva di trasformare in “Parco della
Rimembranza” la zona dove il paese aveva subìto la
distruzione totale. La semplice trama dei “vichi” antichi
avrebbe costituito il disegno dei percorsi nel verde. Il Parco non
è stato ancora realizzato, ma il crinale comincia a prendere
l’aspetto naturalistico di un’area fittamente alberata e
risulta che l’idea di realizzare, nel tempo, un vero e proprio
Parco urbano non sia stata abbandonata. Ciò che resta del centro
storico conserva ormai pochi luoghi ed edifici appartenenti alla
tradizione; tuttavia essi paiono in grado di riprendere almeno in
parte, ma con grande dignità, la funzione identitaria che ebbero
nel passato (Figg.18). Ma intanto il paese ha spostato il suo
baricentro verso le zone di più facile insediamento, verso Nord.
Oggi la parte nuova di Castelnuovo è quattro volte più
ampia e abitata di ciò che resta del vecchio centro. E questo,
io credo, ha dato soddisfazione, ma anche disorientamento a una
comunità già colpita gravemente dal terremoto. Certamente
l’evento sismico, in un paese non grande - come è appunto
Castelnuovo di Conza - ha segnato gli abitanti nel profondo: negli
affetti personali, nei beni, soprattutto nella propria identità
collettiva. In condizioni come queste, cioè quando viene
danneggiata o distrutta “la casa” di una comunità
storicamente radicata e integrata nel proprio ambiente naturale, alla
perdita della forma dei luoghi si accompagna un rischio di allentamento
dei rapporti comunitari. Spetterebbe a chi progetta la ricostruzione,
immaginare la forma del nuovo insediamento come quella di una nuova
“casa” della collettività insediata, una
“casa” pronta ad assecondare o addirittura a stimolare la
rinascita della “recita a soggetto” che è sempre la
vita collettiva. Una recita che non può esistere se non è
“partecipata” e che, dunque, non può essere tale se
il progetto non ha preparato luoghi, spazi, situazioni che possano
prestarsi - secondo i bisogni e l’estro della generazione vivente
- come possibili scene di quella recita. Tuttavia, in generale,
l’uso dei già richiamati moderni “standards”
edilizi e urbanistici indirizza il disegno d’insieme delle
espansioni insediative verso la realizzazione di modelli certamente non
confrontabili con quelli degli insediamenti storici italiani, borghi o
città che essi siano.
Ma non basta.
In questo quadro, dunque, il mantenimento e la cura di ciò
che resta dell’insediamento storico originario nel nuovo
organismo insediativo è fondamentale non soltanto per conservare
un irripetibile bene storico, testimone della cultura da cui
proveniamo, ma soprattutto per mettere a disposizione delle nuove
generazioni la scena più adatta all’espressione dei
momenti più intensi e ricchi di memoria della loro vita
collettiva. Ma non basta; in questo nostro tempo, mentre ci applichiamo
alla restituzione di una “casa” alle comunità
toccate da eventi tragici o dall’incuria, sappiamo che quelle
stesse comunità, da tempo, sono comunque in crisi. Una crisi
lenta forse, ma inevitabile; è la crisi nella quale versa
soprattutto la miriade degli antichi insediamenti minori del territorio
italiano, i “borghi”, che, se non sono raggiunti, divorati
e digeriti dalla periferia delle metropoli, sono lentamente abbandonati
dalle nuove generazioni. Castelnuovo di Conza che aveva circa mille
abitanti la sera del terremoto, oggi ne conta poco più di
cinquecento. Il miglioramento sostanziale delle condizioni abitative,
il rinnovamento di tutto il patrimonio edilizio, la riqualificazione
degli spazi pubblici non è bastato a frenare il fenomeno che io
chiamo “anemia urbana”: prima lo ha accelerato e poi,
forse, ritardato. Ma non lo ha invertito. Il paese, ancorché
modernamente rinnovato, perde circa cento abitanti ogni cinque anni.
Anche per questo l’Amministrazione comunale e i sindaci che si
sono succeduti, spesso appassionati cultori della storia del
“borgo” e del suo territorio, si adoprano per restituire ai
superstiti luoghi del vecchio centro storico l’anima che paiono
aver perso, malgrado la loro riqualificazione; l’anima, dico,
cioè la capacità di attrarre e, allo stesso tempo, di
rappresentare la comunità. Dobbiamo sperare che non sia tardi
mentre il processo di “anemia urbana” prosegue. Nei fatti
non basta ricostruire, riqualificare, risanare. Occorre qualcosa di
più decisivo. C’è bisogno di innovare profondamente
la rete insediativa territoriale di cui i nostri borghi fanno parte,
che, nel nostro caso, ad esempio, è fatta di città -
Salerno, Potenza, Napoli - di campagna fittamente abitata - tra
Castellamare, Pompei, Sarno, Nocera inferiore - e dei tanti borghi e
paesi montani simili a Castelnuovo. L’intento deve essere quello
di fare di ogni centro o agglomerato ancora funzionante un nodo - o una
maglia - di una rete digitale veloce e, soprattutto, di una rete di
trasporto pubblico adeguato alle grandi metamorfosi attuali. Da una
parte, dunque, si tratta di riprendere, con un po’ di
umiltà, la vecchia idea che Giancarlo De Carlo cercò di
attuare molto precocemente a Colletta di Castelbianco - splendido paese
aggrappato all’Alpe ligure - dall’altra, senza timore,
è necessario riesplorare le idee di sistemi di trasporto
pubblico alternativo che hanno addirittura lontane radici storiche,
nell’Ottocento. Ma per venire più vicino a noi, chi non
ricorda la passione degli anni Sessanta per una categoria di trasporti
meccanizzati che avrebbe consentito di superare in linea retta lunghi
percorsi e ardui dislivelli, con sistemi più veloci, più
leggeri di tutti quelli cui poi siamo stati abituati da un pigro
sviluppo industriale? Non sta certo a me, architetto, esplorare la
rinata categoria dei trasporti “ettometrici” (che nome
astruso) funivie, funicolari, ascensori verticali e inclinati, people mover.
Ma certo sta a me indicare come essenziale l’integrazione del
nostro lavoro con quello degli ingegneri informatici, certo, ma
soprattutto dei progettisti delle infrastrutture e dei sistemi di
trasporto, i più evoluti. Perché allora non guardarsi
attorno, nel mondo, con occhi capaci di leggere l’innovazione
dove essa realmente si palesa? perché non comprendere quanta
innovazione “disseminabile” viva già nelle
sperimentazioni di alcuni sistemi di trasporto collettivo che finora ci
sono sembrati soltanto dimostrazioni “di nicchia”, come i
sistemi a fune di Singapore e di un numero crescente di città
maggiori e minori cinesi e sudamericane e i trasporti su elicotteri-bus
pubblici? Come continuare, altrimenti, a credere che ricostruire,
riqualificare, restaurare con la cura nostra, di noi architetti
intendo, sia sufficiente a fare dei nostri borghi, della campagna
urbanizzata, ma anche delle nostre città storiche, i luoghi
privilegiati di un modo di vivere adeguato ai nostri tempi? E
soprattutto adeguato ai bisogni delle generazioni future?
Bibliografia
AA.VV. (1985) - Quaderni della Edina. La ricostruzione a Napoli. Edizioni Edina.
BENJAMIN W. e LACIS A. (2020 [1924]) - Napoli Porosa. Editore Libreria Dante & Descartes.