Fig.
1 - Copertina del numero 1 della
nuova serie di «Zodiac», febbraio
1989.
Fig. 2 - Copertina del numero 1 di Hinterland , dicembre 1977-gennaio 1978, dedicato a Architettura e committenza pubblica: una storia europea.
Fig. 2 - Copertina del numero 1 di Hinterland , dicembre 1977-gennaio 1978, dedicato a Architettura e committenza pubblica: una storia europea.


Fig.
3 - Copertina del numero 8 di «Zodiac
», n.s., ottobre 1992, dedicato
a Laboratorio Latinoamerica.
Fig. 4 - Copertina del numero 11 di «Zodiac », n.s., marzo 1994, dedicato a Architetture in California.
Fig. 4 - Copertina del numero 11 di «Zodiac », n.s., marzo 1994, dedicato a Architetture in California.


Fig.
5 - Copertina del numero 2 di «Zodiac
», n.s., settembre 1989,
dedicato a Storie e progetti di
teatri.
Fig. 6 - Copertina del numero 6 di «Zodiac », n.s., ottobre 1991, dedicato a Su certe devianze dell’archetipo museale.
Fig. 6 - Copertina del numero 6 di «Zodiac », n.s., ottobre 1991, dedicato a Su certe devianze dell’archetipo museale.


Fig.
7 - Copertina del numero 7 di «Zodiac
», n.s., aprile 1992, dedicato
a Università e città.

Fig.
8 - Testimonianza per James Stirling
di Carlo Aymonino e Manfredo Tafuri,
in «Zodiac», n.s., n. 8, ottobre
1992, pp- 4-5.

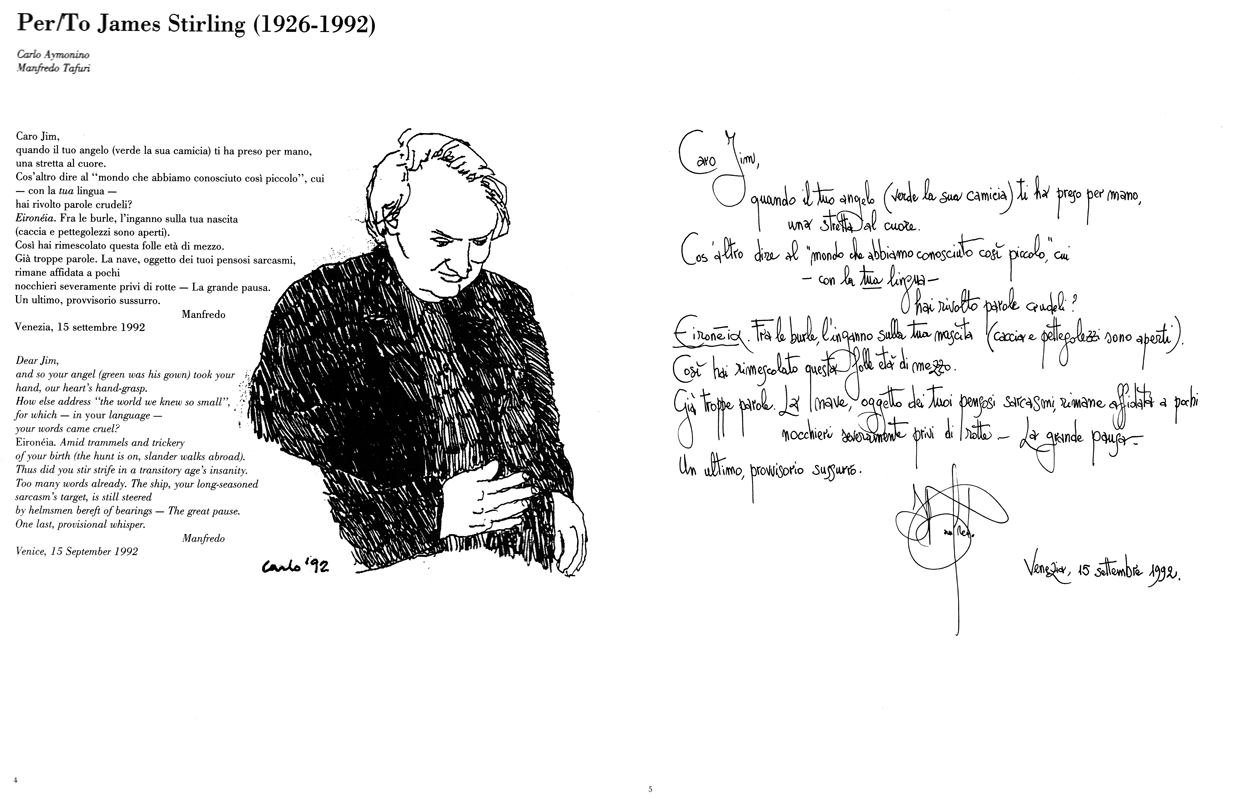
Fig.
9 - Testimonianza per Aldo Rossi di
Carlo Aymonino, Ignazio Gardella
e Philip Johnson, in «Zodiac»,
n.s.,
n. 18, novembre 1997, pp- 4-5.
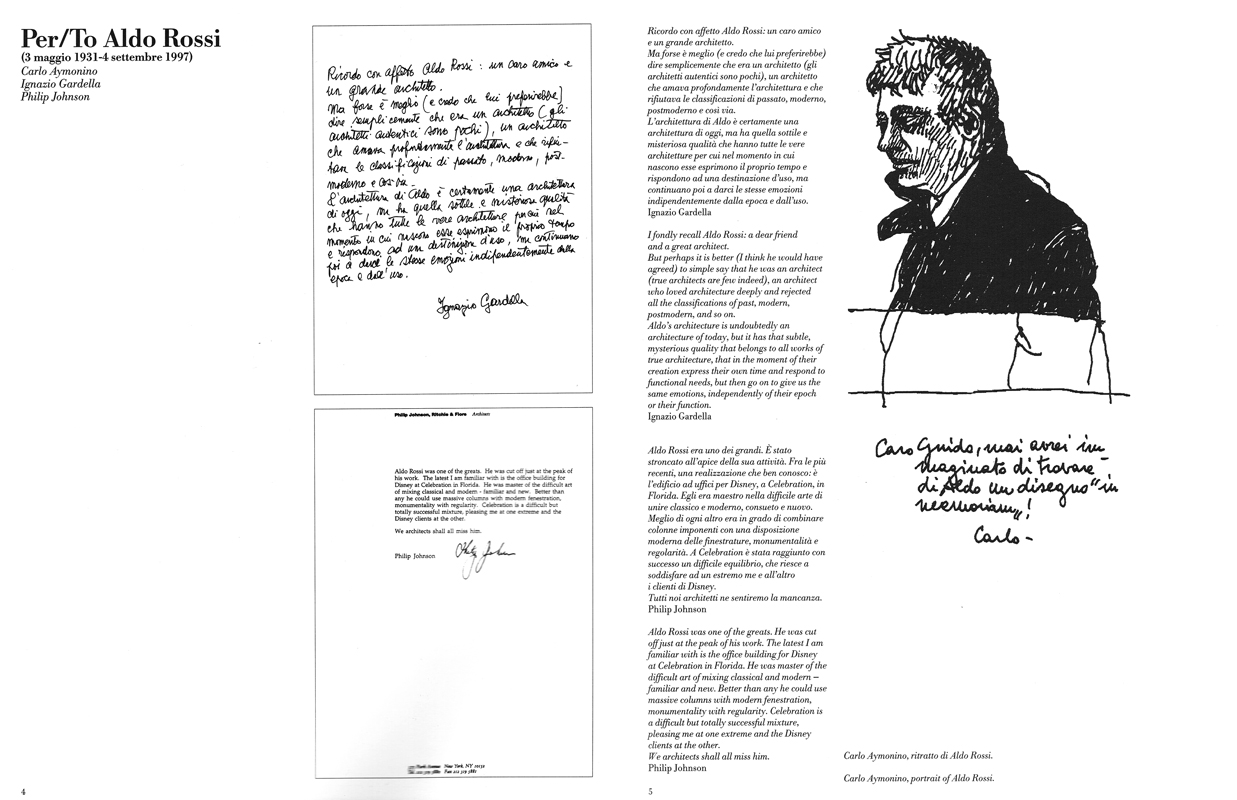
Fig.
10 - Pagine iniziali del saggio di Julius Posener La costruzione del
teatro a Berlino da Gilly a Poelzig, in «Zodiac»,
n.s., n. 2, settembre 1989, pp. 6-7.

Fig.
11 - Due pagine di regesto nel numero
dedicato alla generazione degli
architetti nati intorno al 1920, in
«Zodiac», n.s., n. 16,
novembre
1996, pp- 34-35.
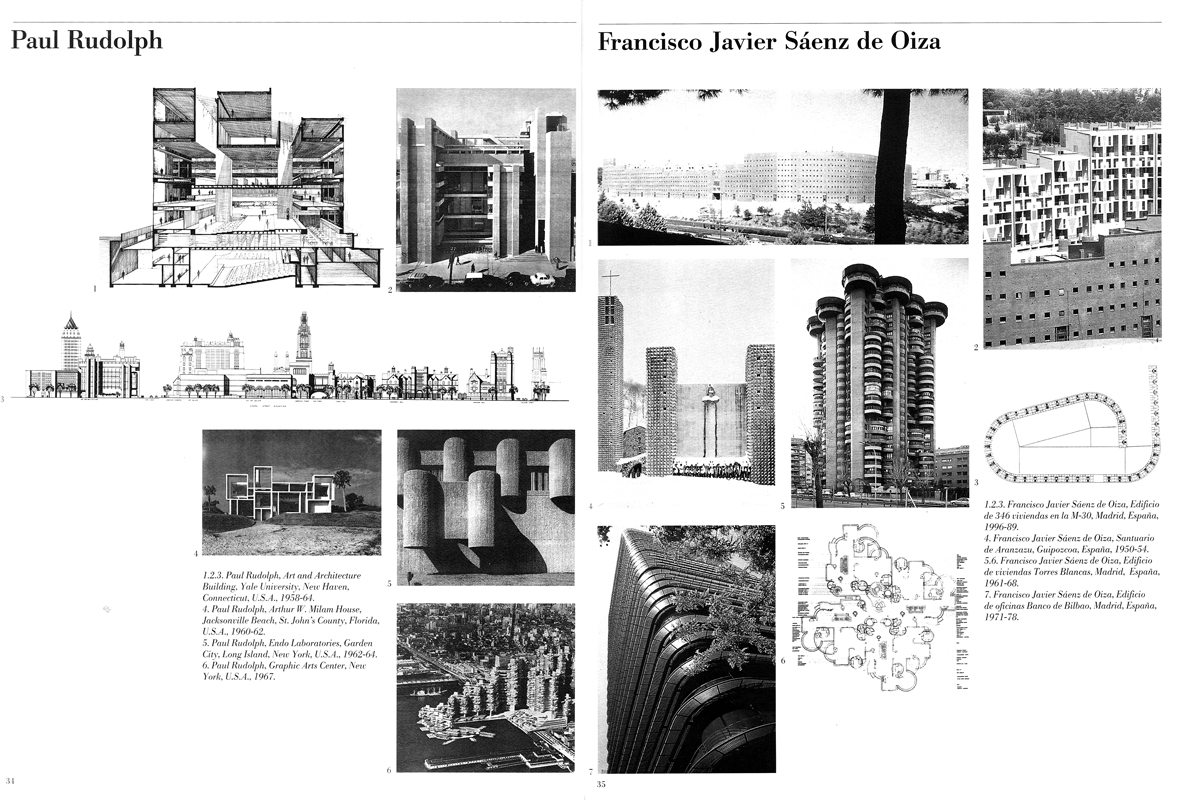
Fig.
12 - Guido Canella, Lettera di invito
per ricordare Ernesto N. Rogers a
vent’anni dalla morte, in
«Zodiac»,
n.s., n. 3, aprile 1990, p. 14.
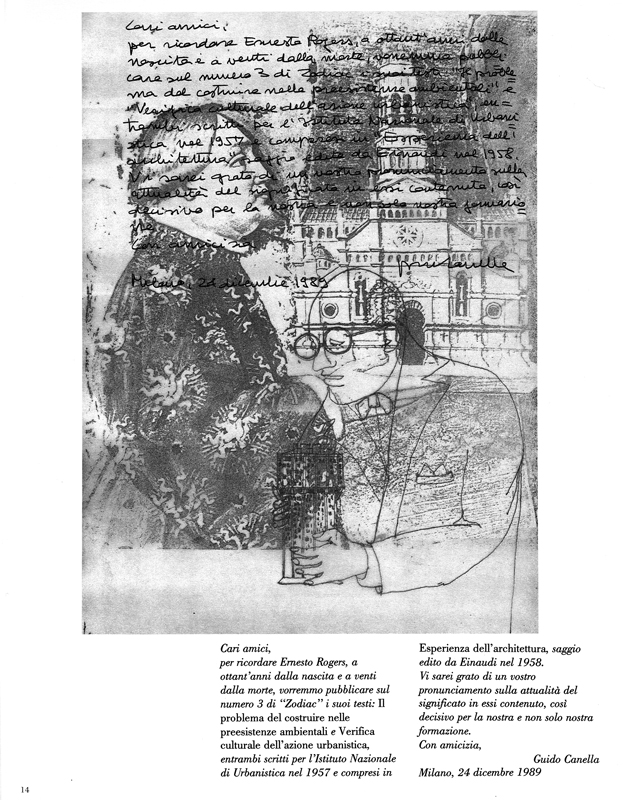
Fig.
13 - Giovanni Testori, Pagine iniziali del contributo Per il
completamento
del Sacro Monte di San Carlo ad Arona, in
«Zodiac», n.s., n. 9,
giugno 1993, pp. 64-65. Per quel numero Canella aveva
invitato
alcuni architetti e amici della testata ad avanzare alcune
proposte
per il completamento del Sacro Monte di San Carlo ad
Arona
rimasto inconcluso. Testori, allora in ospedale, aveva
contribuito
con un ritratto di San Carlo e alcuni stralci dai suoi
Trionfi. All’invito
di Canella avevano aderito Carlo Aymonino, Ignazio
Gardella,
Philip Johnson, Gianugo Polesello, Aldo Rossi, Luciano
Semerani.
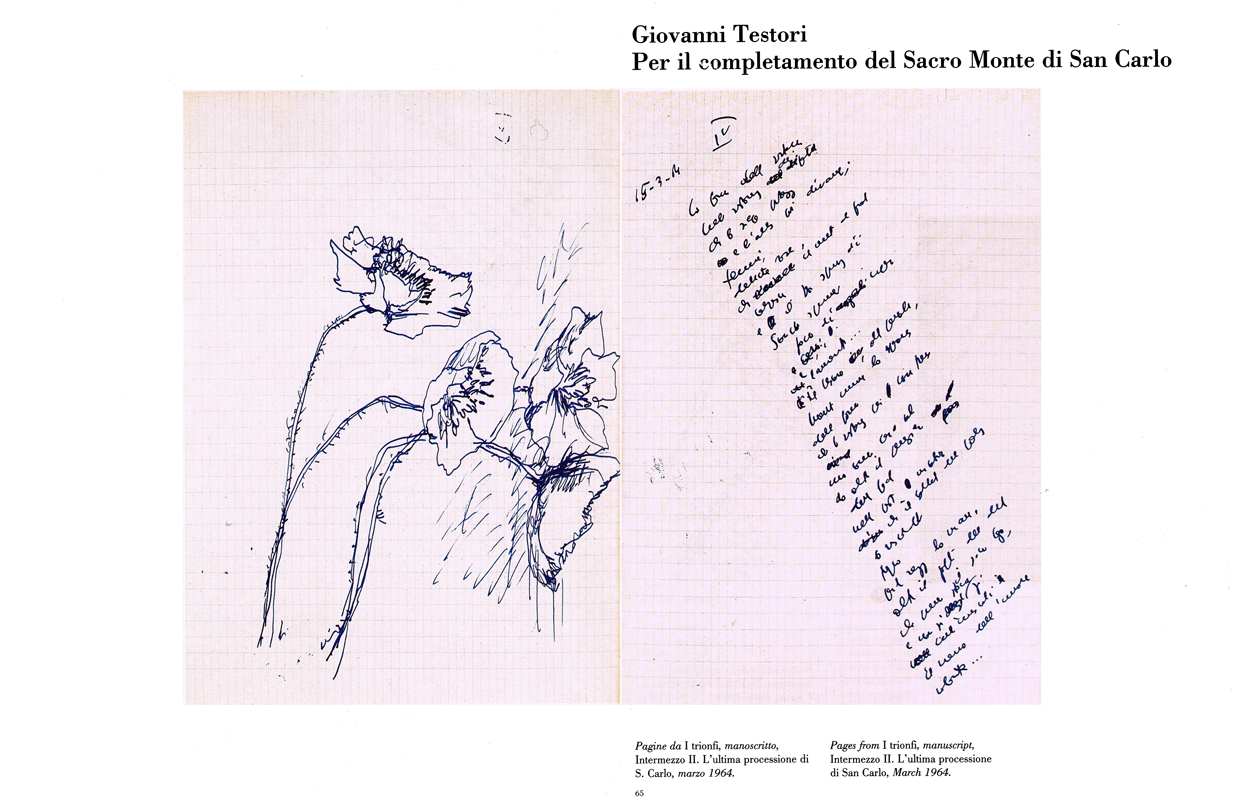
Fig.
14 - Carlo Aymonino, Testimonianza per
Ernesto N. Rogers a vent’anni dalla
morte, in «Zodiac», n.s., n. 3,
aprile
1990, pp. 20-21.
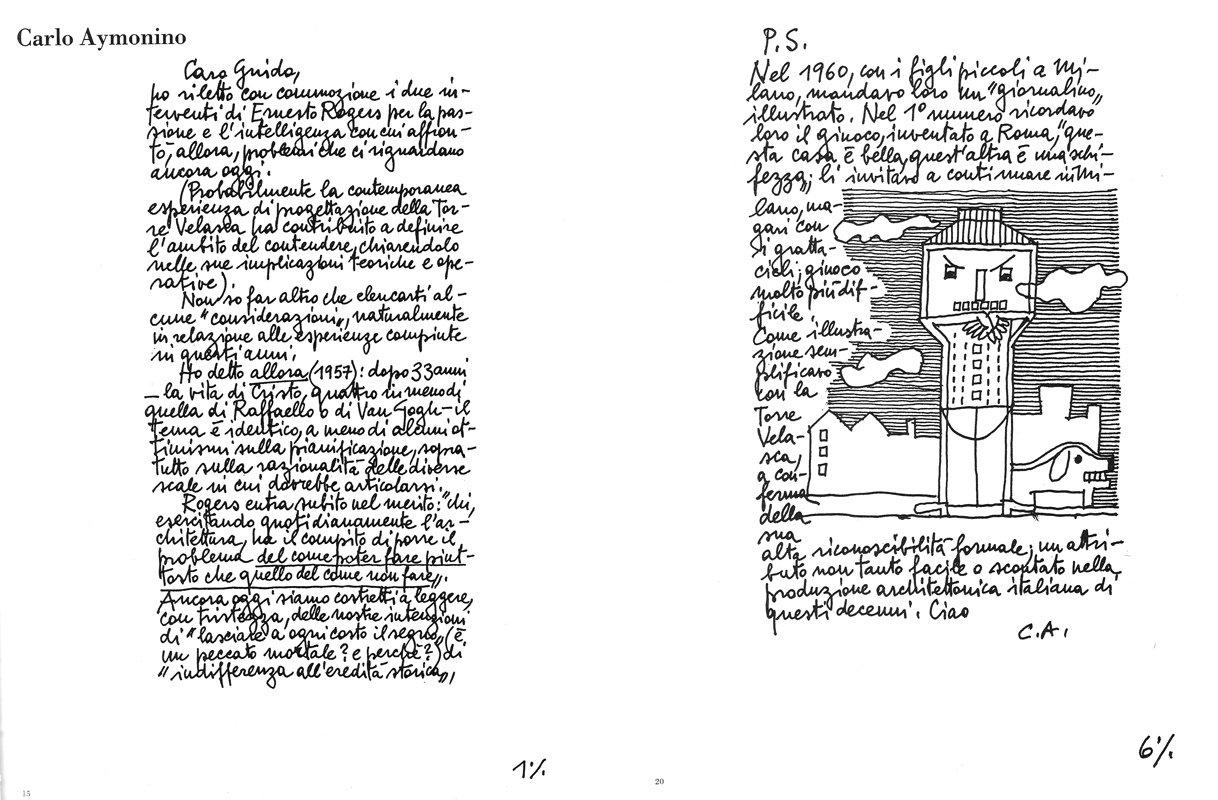
Fig.
15 - Copertina del numero 21 di «Zodiac
», ultimo della nuova serie,
dicembre 1999, dedicato a La critica
di architettura dopo Zevi.
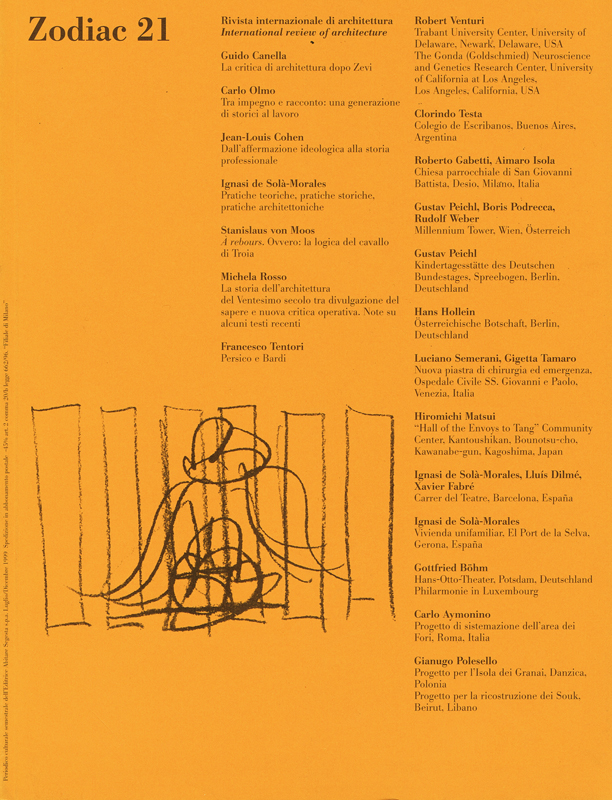
Fig.
16 - Comitato d’orientamento per
l’impostazione
dei numeri 5 e 6 nella
residenza dell’editore Renato
Minetto a Sestri Levante, 28-29
luglio 1990: si riconoscono Carlo
Aymonino, Guido Canella, Ignazio
Gardella, Renato Minetto, Renzo
Zorzi.
