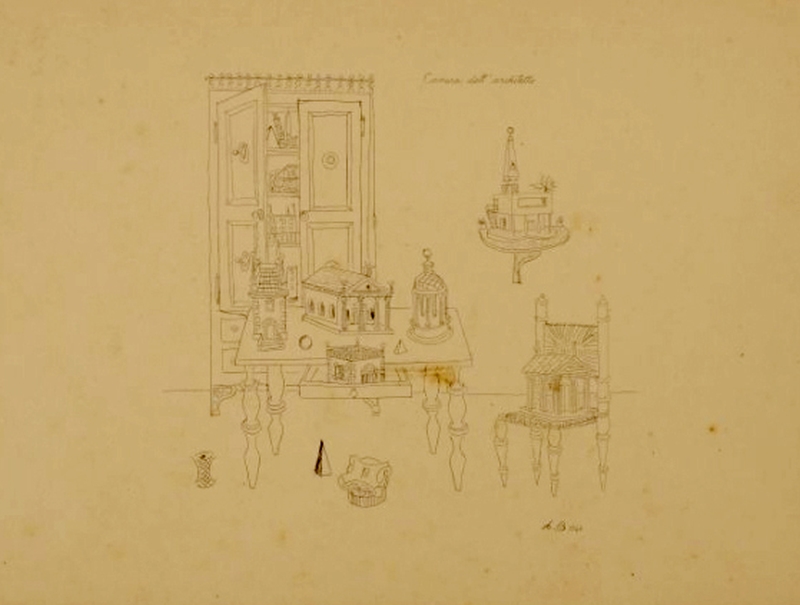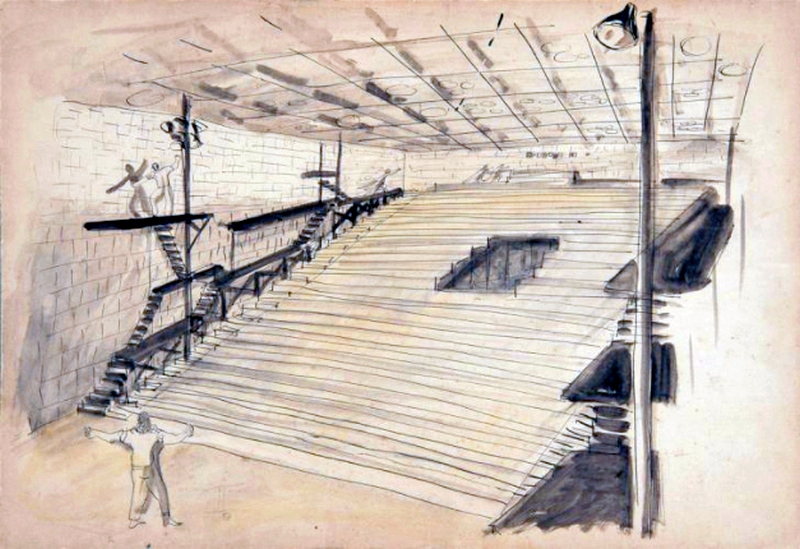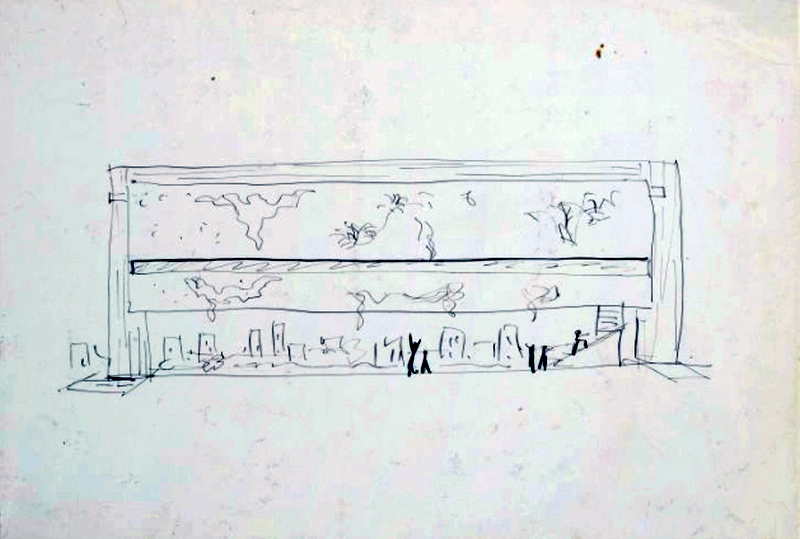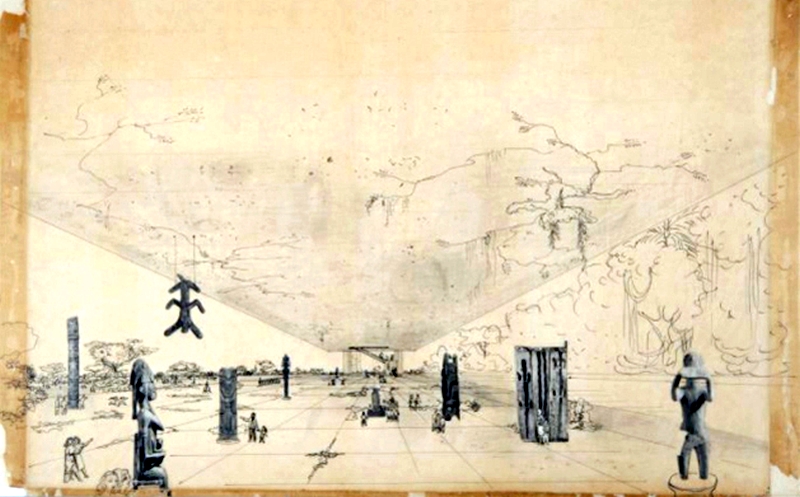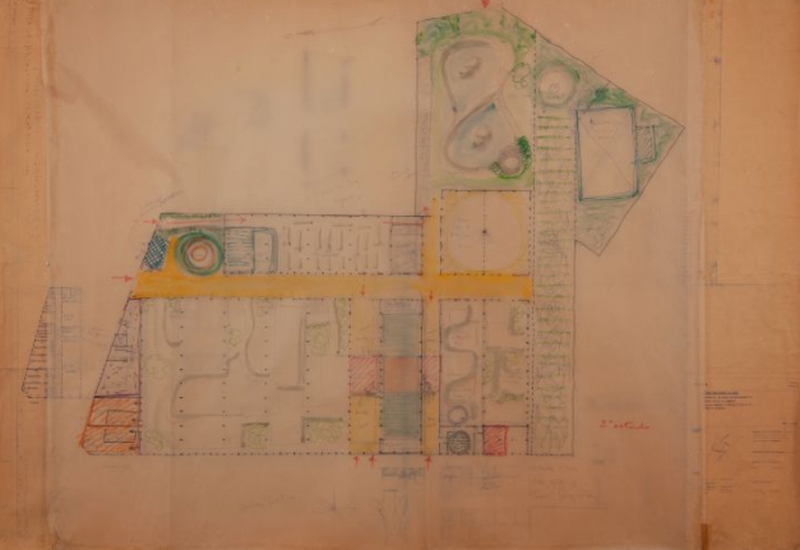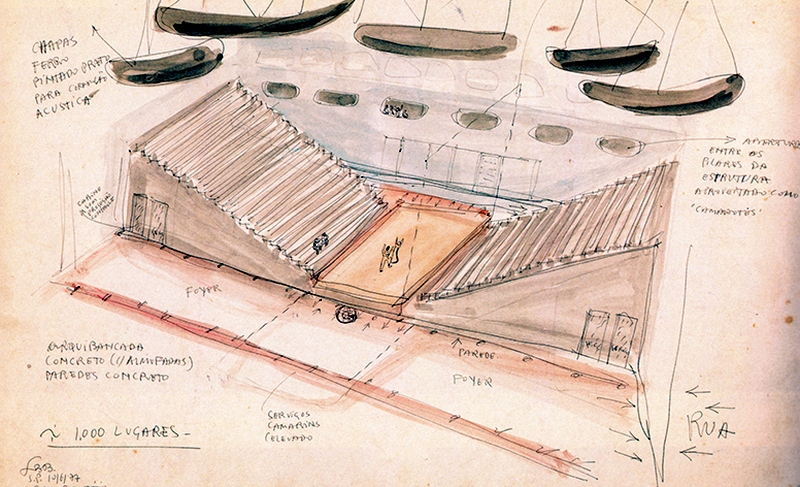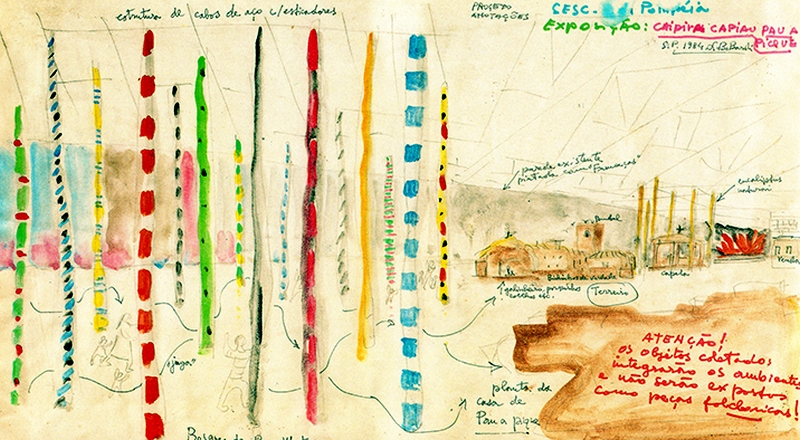L’invenzione della felicità.
Il disegno in Lina Bo Bardi
Caterina Lisini
Fig.
1 - Lina Bo Bardi, litografia “Camera
dell’architetto”.
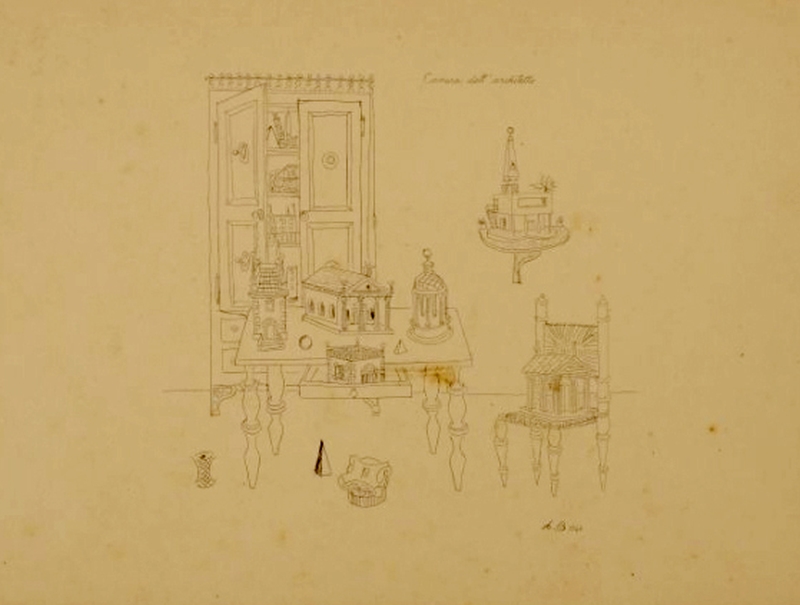
Fig.
2 - Lina Bo Bardi, MAMB prospettiva del Teatro.
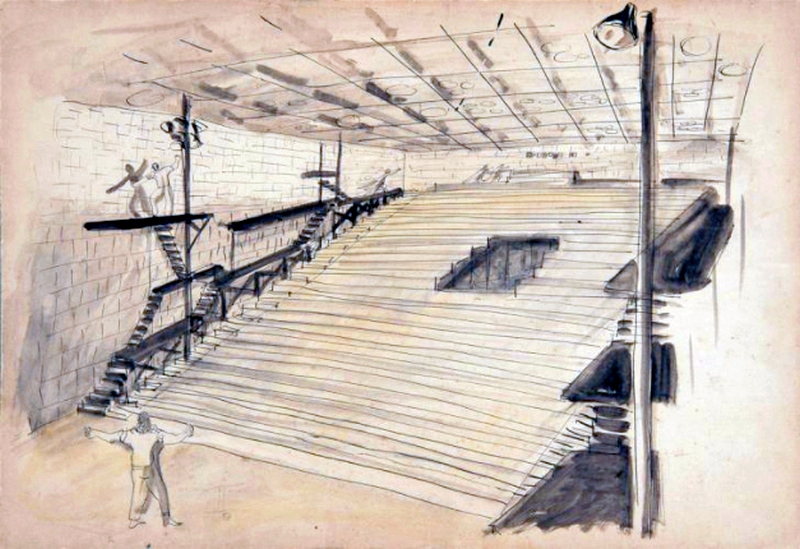
Fig.
3 - Lina Bo Bardi, schizzo di studio per il costume di scena per
"Caligola".

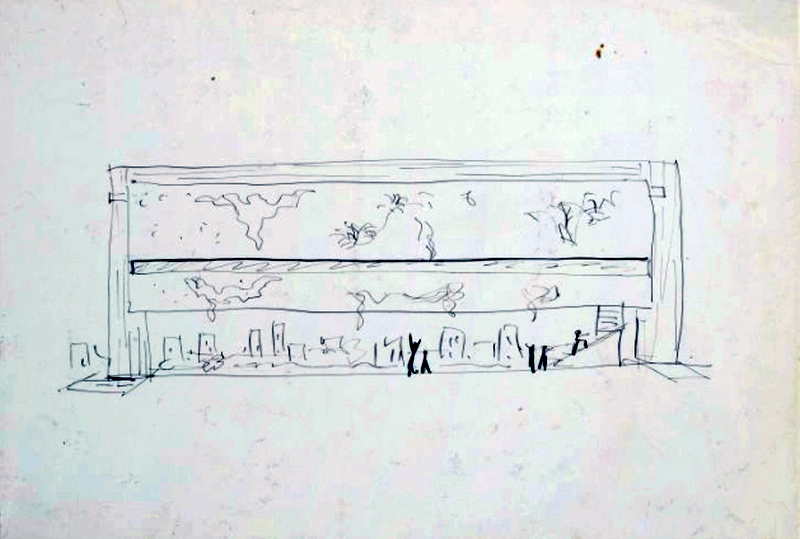
Fig.
4 - Lina Bo Bardi, MASP, schizzo di studio per la facciata.
Fig.
5 - Lina Bo Bardi, MASP, prospettiva del Belvedere.
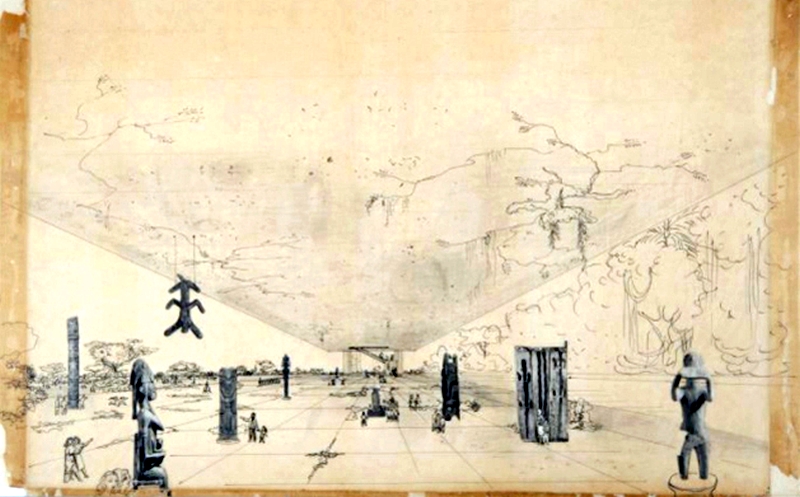
Fig.
6 - Lina Bo Bardi, SESC da Pompéia, studio planimetrico.
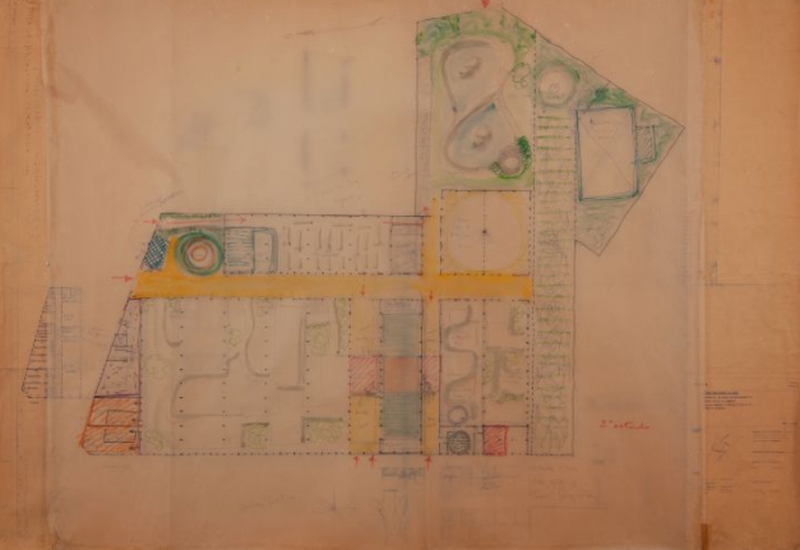
Fig.
7 - Lina Bo Bardi, SESC da Pompéia, prospettiva del Teatro.
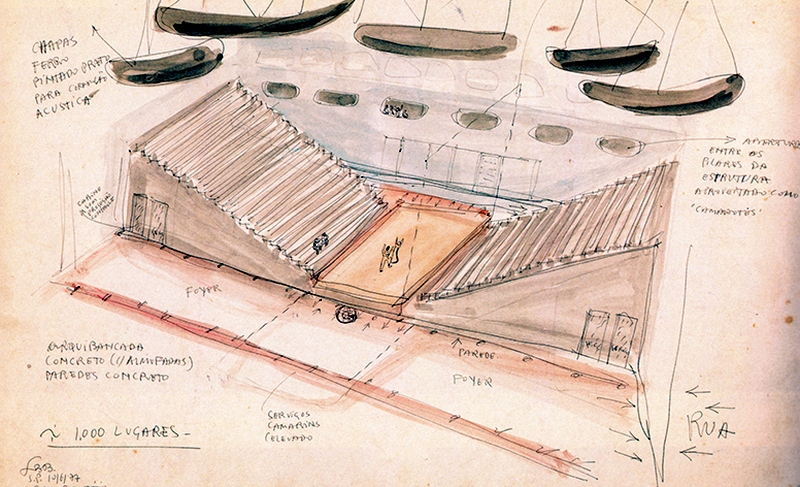
Fig.
8 - Lina Bo Bardi, SESC da Pompéia, schizzo di studio per la
mostra “Caipiras, capiaus: pau-a-pique”.
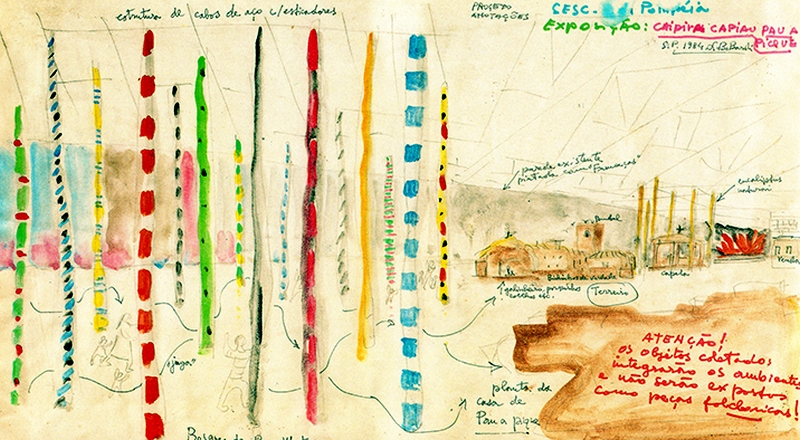
«Lo scrivere non mi interessa», dice con
sobria franchezza Lina Bo Bardi a Francesco Tentori, «so
perfettamente di saper scrivere bene. I miei maestri sono Stendhal e
Majakowskij. Il primo mi ha insegnato la concisione, quando
annotò di aver imparato a scrivere dai direttori del catasto
edilizio francese e dagli estensori degli articoli del Codice Civile.
Il secondo, invece, mi ha insegnato il ritmo, la fantasia del
reale» (Tentori 2004, p. 151).
Anche il disegno, nella Bo Bardi, sembra vivere di una analoga
doppia anima, fino a una multiformità di valenze
straordinariamente feconde. Non solo, o non tanto, disegni di
architettura, disegni tecnici funzionali al progetto,
all’esecutivo, al cantiere. Ma neppure disegni semplicemente
ideativi, schizzi di studio, disegni di ricerca teorica o
d’espressione. E neppure, ancora, disegni di viaggio, di
impressione, di fantasia. I suoi disegni, dal tratto a volte di
impronta un po’ naïf, altre volte minuziosamente
precisi e costruttivi, variati in tante tecniche, dallo schizzo a
matita, alla gouache, all’acquerello,
al disegno a china, al collage, e spazianti su temi e scale
estremamente variegati, semplici oggetti d’uso, mobili,
gioielli, vestiti, singole case d’abitazione, complessi di
residenza popolare, edifici pubblici di grande scala e
complessità e poi ancora scenografie teatrali e allestimenti
museali ed espositivi, nel loro insieme sembrano tutti segnati
dall’apparente, dichiarato ossimoro: «la fantasia
del reale».
In piena guerra, nell’agosto 1942, la rivista
“Domus”, allora passata sotto la direzione
d’emergenza composta da Melchiorre Bega, Massimo Bontempelli
e Giuseppe Pagano, chiede «ad alcuni architetti di raccontare
[…] con intima confidenza, l’ideale progetto di
una loro casa di sogno», un tema sfuggente, quasi
«a disegnare l’impossibile» (Redaz. Domus
1942, p. 312), tanto da poter essere declinato, nelle molte
‘confessioni’ che seguono (Banfi, Belgiojoso,
Zanuso, Cattaneo, Diotallevi e Marescotti, Cocchia, Bianchetti e Pea,
Mollino, Pica e altri) come simbolica casa razionalista, come
spirituale casa astratta, come argomento di pura evasione, come
fantasticheria autobiografica. Tra i molti disegni conservati da Lina
Bo Bardi del suo periodo di formazione prima a Roma e poi a Milano, una
litografia su carta del 1943, dal titolo Camera
dell’architetto sembra poter appartenere a questa
galleria di riflessioni, offrendo l’autoritratto, ironico e
meditativo, di un periodo della sua vita che sta per concludersi e
rivelando già in nuce una costante
della sua opera, l’intrecciarsi profondo tra disegno e
autobiografia. Su di una parete appena accennata un armadio in stile,
con le ante semiaperte, fa da sfondo borghese ad un tavolino dalle
gambe tornite a cui è affiancata una tradizionale sedia
impagliata: l’intero spazio domestico è affollato
da una moltitudine di modelli di architettura, per lo più di
fantasia, dove si incontrano, in primo piano, un tempio classico e un
tempietto rinascimentale, un frammento di villa palladiana ed elementi
di abitazioni storiciste mentre a terra un capitello ionico
è accostato ad astratti solidi geometrici.
Dall’armadio affiorano sagome di architetture più
connotate: obelischi, una torre medievale, la torre di Pisa, il
Colosseo, e su di un lato, isolato sopra una piccola mensola, trova
posto il modello di un’architettura moderna, connotata da pilotis
e fenȇtre en longueur, che cela parzialmente un
alto obelisco. Più che un’allegoria, il tratto
continuo del disegno, da illustrazione, che non fa sfoggio di alcun
virtuosismo tecnico, sembra rappresentare un allegro coacervo,
stemperando in un’immagine lieve la molteplicità
di riferimenti del bagaglio culturale dell’architetto, messi
tutti insieme, senza gerarchie, piuttosto in muto dialogo tra di loro.
Evidente è il segno di indirizzo culturale lasciato dalla
collaborazione svolta, assieme a Carlo Pagani, alle imprese editoriali
di Gio Ponti negli anni 1940-1943, che la vedono quasi abituale
presenza nell’ultima annata di “Domus”, e
con continuità su “Stile”, dove si
occupa di arredamento, architettura d’interni, illustrazione
e grafica, arrivando a disegnare molte copertine della rivista, e
persino sporadicamente su altre riviste della galassia pontiana, quali
“Aria d’Italia”,
“Bellezza”, “Vetrina e
negozio”. Tuttavia nel 1943 nuove inquietudini stanno
attraversando la vita della Bo Bardi e sembrano trapelare dal senso di
sospensione del disegno: le vicende drammatiche della guerra,
l’impasse del razionalismo e i nascenti
dibattiti in seno ai gruppi dei giovani architetti,
l’incontro con Pietro Maria Bardi, il crescente bisogno di
affermare le proprie convinzioni personali le rendono angusto
l’orizzonte classico e idilliaco del milieu di
Gio Ponti.
Irrompono l’urgenza della realtà e nuove
consapevolezze: «Vedevo il mondo intorno a me,
scriverà la Bo Bardi qualche anno più tardi, solo
come realtà immediata, e non come esercitazione letteraria
astratta» (Carvalho Ferraz 1994, p. 10).
Prende corpo così una visione architettonica e
delle opere umane sempre tenacemente aderente alla realtà,
una realtà che per la Bo Bardi, da quando approda nel 1946 a
Rio de Janeiro, città principe dello spirito brasiliano,
è intrisa di speranza e di vitalità, a cui Lina
risponde con una creatività spontanea e impetuosa,
– «furiosa» la definisce Semerani (2012,
p. 8)–, inseparabile dalla esperienza del corpo e dalla
fisicità del reale, esercitata nel plasmare progetti
rigorosi subito contaminati con festose e ironiche evocazioni.
«Architettura come spazio abitato, umano, scrive la
Bo Bardi nei primi anni Cinquanta, è una realtà
potente, responsabile del comportamento dell’uomo,
responsabile perfino della sua felicità. E in questo senso
il Movimento Moderno continua» (Carvalho Ferraz 1994, p. 86).
Tra i disegni elaborati per il Museu de Arte Moderna da Bahia
(MAMB), nati all’interno della complessa rifondazione
culturale maturata negli anni dell’esperienza di Bahia e
dell’esplorazione del Nordeste
brasiliano[1],
spiccano quelli elaborati per la realizzazione del teatro
«uno dei mezzi più diretti di propaganda
culturale, dato che sintetizza tutte le altre arti» (Carvalho
Ferraz 1994, p. 144) . Su di una carta è tratteggiata, con
pochi tratti di grafite e inchiostro, rimarcati dalle consuete
pennellate ad acquarello, la prospettiva della cavea del pubblico,
costruita con semplici impalcati di tavole di legno e racchiusa da un
intrico di tralicci e scale percorribili, praticabili anche per
l’azione scenica, nella forma quasi di ramificazioni
vegetali. Nessuna aggettivazione formale o scenografie superflue,
nessuna divisione funzionale tra spazio del pubblico e spazi tecnici,
abolizione della meccanizzazione scenica, contiguità tra
azione della rappresentazione e spettatori data dalla
prossimità dell’improvvisato palcoscenico e come
sfondo la nudità della grande struttura del Teatro Castro
Alves ancora parzialmente distrutta dall’incendio del 1958.
Un teatro popolare moderno, semplice, «povero ma
violentemente emotivo» (Carvalho Ferraz 1994, p. 144). Gli
schizzi di studio della Bo Bardi sembrano appropriarsi della profonda
lezione di semplificazione[2]
mutuata dall’esperienza popolare di Bahia: nei loro tratti
non è presente alcuna originalità o gratuita
invenzione ma anzi la costante ricerca di essenzialità e la
propensione per un’architettura ‘povera’
e spoglia e per materiali grezzi e non rifiniti sembra scaturire
direttamente dalla traduzione dello stretto legame tra
necessità umane e il loro soddisfacimento, tra
utilità e bellezza. In questo caso il disegno per la Bo
Bardi non è solo un momento di approccio al progetto ma
diventa riflessione esistenziale e sociale, espressione tout
court della sua poetica, riassumibile, secondo le sue stesse
parole, in quella tenace «ricerca antropologica nel campo
delle arti contro la ricerca estetica» (Carvalho Ferraz 1994,
p. 216). E quando i suoi disegni si popolano e si colorano di figure e
di forme, sono la realtà dell’ambiente umano
brasiliano e la specificità della comunità di
destinazione che agiscono, ‘sporcando’ il foglio
con innesti e contaminazioni. Così nel suo lavoro la
memoria, il rapporto con le manifestazioni culturali e la tradizione
popolare non è mai nostalgia, una mera rivisitazione del
passato per amore del passato, non è neppure un atto
critico, un’interrogazione del tempo per comprendere
l’arte o la disciplina, è piuttosto un moto di
continua meraviglia, esperito quasi con gli occhi di un bambino, uno
stupore per un giacimento di forme, per un groviglio di espressioni ed
esperienze, tutte umane, indispensabili ad alimentare
l’immaginario della sua arte.
Moltissimi, e distribuiti in un arco temporale che va dal 1957
al 1966, sono gli studi per la soluzione dei tamponamenti di facciata
del grande portale del Museu de Arte de São Paulo (MASP),
sospeso iconicamente ad un’estremità
dell’Avenida 9 de Juhlio. La versione più cara
alla Bo Bardi, e da lei tenacemente esplorata per molto tempo, vede il
corpo sopraelevato del Museo come un unico possente monolite in
cemento, illuminato dall’alto, densamente materico e
completamente cieco, ad eccezione di una lunga feritoia orizzontale in
corrispondenza del livello delle esposizioni temporanee, e interamente
ricoperto di incrostazioni vegetali, che disegnano una trama irregolare
di piante tropicali affiorate «tra gli interstizi del cemento
bruto, come fra le pietre di una vecchia cattedrale» (Lima
2021, p. 259). Nella stessa serie, una prospettiva insolita del
Belvedere, tratteggiata proprio sotto l’imponente impalcato
del museo e in asse con questo, tanto da sembrare allungata quasi
all’infinito, raffigura tra le efflorescenze della
vegetazione schizzate a matita, un collage di grandi sculture tribali,
disposte libere nel vasto spazio e circondate dalla popolazione dei
visitatori, quasi a saggiare la visione di una nuova società
capace di immaginare una sovrapposizione senza soluzione di
continuità di arcaiche manifestazioni d’arte e
creatività contemporanea.
Lina Bo Bardi disegna ciò che sta pensando e
progettando, anzi pensa disegnando e contemporaneamente pensa guardando
il mondo. A guidare la sua mano, come in ogni autentico artista, sembra
esserci «la testa quadrioculare» indagata da un
contemporaneo come Tullio Pericoli (2021, pp.43 e 41), «con
la sua doppia coppia di occhi, una sulla fronte e una nel
cervello», la vista materiale e la vista
dell’intelletto che non possono fare a meno l’una
dell’altra così come «non è
possibile guardare senza coinvolgere il cuore e la mente».
Anche i suoi disegni più specificamente architettonici
raramente hanno qualcosa di concettuale, lontani dall’essere
levigati, hanno un che di immediato, di spontaneo, di vitalistico, una
specie di corrente continua tra arte e vita, quasi fatti per se stessa
– la Bo Bardi ha confessato: «Lavoro di notte,
quando tutti dormono, […] e intorno è
silenzio» (Dos Santos 1993, p. 17) –, per la
urgenza di mettere in carta il pensiero mentre si forma.
C’è nei disegni di Lina (così,
col solo nome, è chiamata affettuosamente ancora oggi quasi
dovunque in Latinoamerica) una conflittualità, o meglio una
fruttuosa compresenza, tra una propensione razionale da un lato, che
ben si sposa con la sua formazione eurocentrica, e una vena surrealista
dall’altro, che si fonde con l’adesione istintiva
alla cultura popolare, ai miti, ai riti ancestrali della tradizione
locale: quell’«incanto», come
dirà, provato immediatamente al suo arrivo a Rio,
«una speranza reale quasi quotidiana, non metafisica, nella
semplicità delle soluzioni architettoniche, nei ciao umani,
cose sconosciute per una generazione che arrivava da molto
lontano» (Carvalho Ferraz 1994, p. 12).
Il surrealismo sembra conquistare interamente i disegni del
Centro per il tempo libero SESC Fábrica da
Pompéia, ricavato nella periferia industriale di San Paolo
con la riconversione di un’antica fabbrica di fusti
metallici, che dimostrano, nell’ingente numero di schizzi e
prove, la straordinaria capacità con cui la Bo Bardi riesce
a tenere insieme le diversissime scale del progetto, dalle alte
‘torri’ in cemento degli impianti sportivi fino al
disegno minuto degli arredi, delle divise dei lavoratori e persino
delle indicazioni pubblicitarie. «Come in ogni ricerca
surrealista, da Savinio a Picasso, da Breton a Buñuel o
Jarry, sono le immagini e i materiali che generano la composizione per
cui il meccanico e l’organico, il puro e l’impuro,
il desiderio e il caso, attraversano le frontiere che li
separano» (Semerani e Gallo 2012, p. 29). Ma nel caso della
Bo Bardi vi si aggiunge in più una capacità
ermeneutica: si tratta di un’attitudine a disegnare e mettere
in scena «il frusciare inavvertibile della vita»
che sembra apparentare il suo percorso artistico a quello di una
scrittrice come Natalia Ginzburg, un’altra straordinaria
figura femminile del Novecento, a lei coeva. «È il
piacere di adoperare la mente come le viscere, di fare camminare la
mente nell’oscurità, non essendo il viaggio e la
peripezia della conoscenza intellettuale altro che lo specchio appena
un po’ annerito dove si riflette ciò che in quelle
profondità […] è buio ma
leggibile» (Garboli 1989, p. 116 e 106). Probabilmente per
entrambe una facoltà tutta feminina di
inclusione e appropriazione del mondo che sembra guidare la mano sicura
con cui la Bo Bardi delinea le sue creazioni.
Fin dai primi elaborati planimetrici
nell’intersezione a croce dei lunghi percorsi pubblici
esterni che distribuiscono il centro è posto un teatro,
simbolo della vita e della partecipazione. Un significativo schizzo
prospettico mostra, nel rettangolo allungato dell’ex
capannone, lo schema compiuto di un moderno teatro a scena centrale
interamente in cemento, con il blocco monolitico delle due gradonate a
cavea contrapposte circondato da gallerie lineari in quota, che
ospitano ulteriori spazi per il pubblico, alla maniera di balconate con
vista di lato e dall’alto sulla scena, e animato dalle
presenze scultoree di grandi piastre in acciaio color argento, come i Mobiles
di Calder, appese in alto in funzione acustica. Tutto
intorno, nei capannoni liberati dalle tamponature interne le
attività ludiche e culturali, come la biblioteca, gli
ateliers, gli spazi per la lettura e per il gioco dei bambini, le aree
per la sosta e per le esposizioni, il vasto living
con l’intaglio evocativo di un corso d’acqua e la foguiera
– il grande focolare –: tutti luoghi per la
socializzazione intrecciati e intercomunicanti in una ricercata
‘accidentalità’ che è
l’accidentalità della vita. Tutti i disegni della
Bo Bardi, pieni di voci e colori, sembrano spargersi in mille rivoli di
accesa creatività che investe persino gli arredi, come le
sedute del teatro, austere, interamente in legno massiccio, non
imbottite né rivestite in velluto come nei teatri di corte
del Settecento e nel comfort contemporaneo, pensate per
«restituire al teatro la sua proprietà di
distanziare e coinvolgere». I disegni, anche quelli
più compiutamente architettonici, non hanno mai il fine di
presentare un’opera o una creazione, un intento di proposta
professionale, sono piuttosto strumenti di ricerca e di conoscenza. Su
di essi aleggia ininterrottamente un’atmosfera festosa,
un’ironica ilarità, che è inscindibile
nella Bo Bardi da una forma di comprensione o di saggezza della vita, e
che sembra riassumere la sua peculiare e particolarissima invenzione
della felicità. «Todos juntos»,
vuole Lina i destinatari del suo Sesc Pompéia,
«giovani, bambini, terza età, tutti uniti nel
piacere di ritrovarsi insieme, nel danzare, nel cantare» (Bo
Bardi 1992, p. 225).
Note
[1]
Lina Bo Bardi si reca a Salvador de Bahia per la prima volta nel
febbraio del 1958. Vi ritorna nel 1959 e vi rimane fino
all’agosto del 1964, pochi mesi dopo il colpo di stato
militare. Su questa esperienza pubblica nel 1967 un articolo dal titolo
Cinco anos entre os brancos (“Mirantes
das artes etc”, 6, novembre –dicembre) poi tradotto
in Cinque anni tra i bianchi (Carvalho Ferraz
1994, pp. 161-162).
[2]
Sul significato di ‘semplificazione’ per Lina Bo
Bardi si vedano le sue parole negli scritti Museu de Arte de
São Paulo e Mostra Nordest (Carvalho
Ferraz 1994, pp. 100 e 158).
Bibliografia
BO BARDI L. (1953) – “Museo sulla sponda
dell’oceano”. Domus, 286, 15.
BO BARDI L. (1974) – “Sulla linguistica
architettonica”. L’Architettura, 226.
BO BARDI L. (1987) – “Centre
Socio-Culturel SESC Pompéia”.
L’Architecture d’Aujordhuj, 251, 6-9.
BO BARDI L. (1992) – “Centro de Lazer SESC
“Fábrica da Pompéia, São
Paulo, Brasil, 1981-89”. Zodiac, 8, 224-229.
CARVALHO FERRAZ M., (a cura di) (1994) – Lina
Bo Bardi. Charta-ILBPMB, Milano-São
Paulo.
CRICONIA A., (a cura di) (2017) – Lina Bo
Bardi. Un’architettura tra Italia e Brasile.
Franco Angeli, Milano.
DE OLIVEIRA O. (2000) – “Lina Bo Bradi,
architetture senza età e senza tempo”. Casabella,
681, 36-55.
DOS SANTOS R. C. (1993) – “Lina Bo Bardi:
l’ultima lezione”, intervista. Domus, 753,
17-24.
GALLO A., (a cura di) (2004) – Lina Bo
Bardi architetto. Marsilio, Venezia.
GARBOLI C. (1989) – Scritti servili.
Einaudi, Torino.
LIMA ZEULER R. M. DE A. (2019) – Lina Bo
Bardi, Drawings. Princeton University Press, New Jersey,
USA.
LIMA ZEULER R. M. DE A. (2021) – La dea
stanca. Vita di Lina Bo Bardi. Johan & Levi Editore,
Milano.
MAGNAGO LAMPUGNANI V. (1990) – “Centro
sociale e sportivo «Fabbrica Pompéia»,
San Paolo”. Domus, 717, 50-57.
PERICOLI T. (2021) – Arte a
parte. Adelphi, Milano.
PONTI G. (1953) – “Casa de
Vidro”. Domus, 279, 19-26.
REDAZ. DOMUS (1942) – “La casa e
l’ideale”. Domus, 176, 312.
SEMERANI L. e GALLO A. (2012) – Lina Bo
Bardi. Il diritto al brutto e il SESC-fàbrica da
Pompéia. Clean, Napoli.
TENTORI F. (2004) – “Ricordo della Signora
Lina”. In: Gallo A., (a cura di), Lina Bo Bardi
architetto. Marsilio, Venezia.