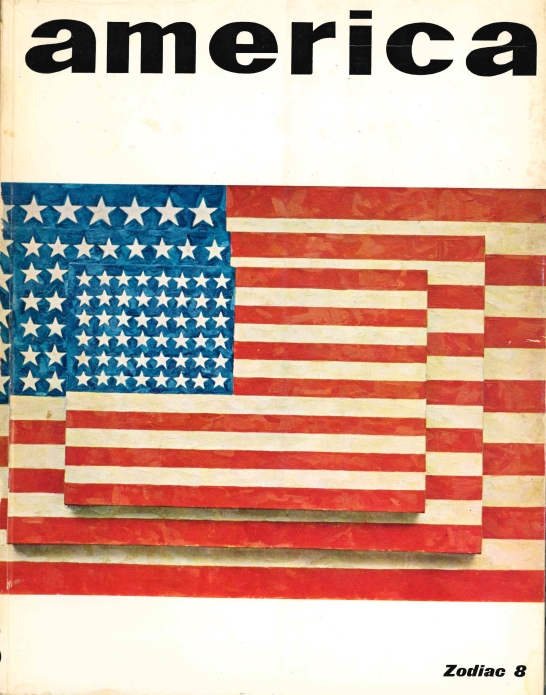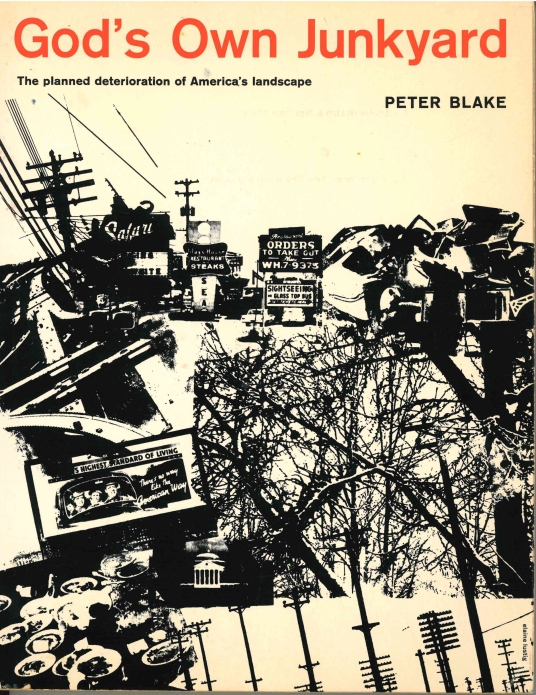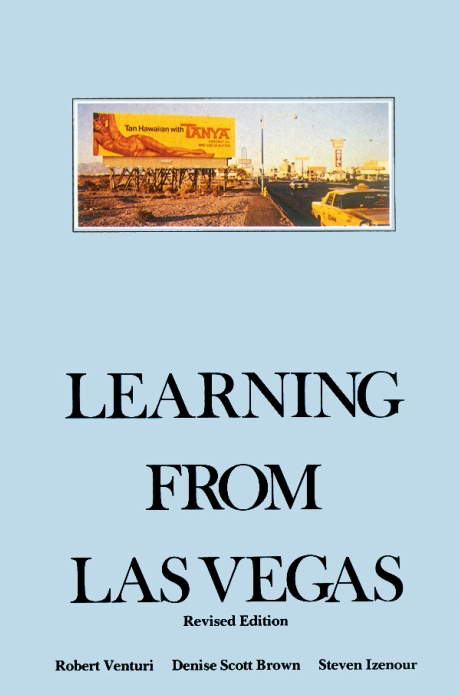USA: l’immagine del nostro avvenire?
Ugo Rossi
Fig. 1 - Bruno Zevi, Verso un’architettura organica, copertina.

Figg. 2-3 - Casabella 281, 1963, copertina. Zodiac 8, 1961, copertina.

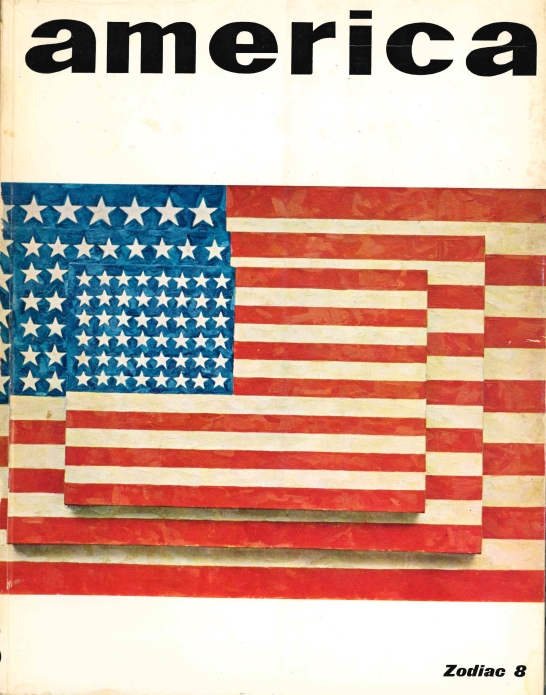
Fig. 4 - Peter Blake, God’s Own Junkey, 1963, copertina.
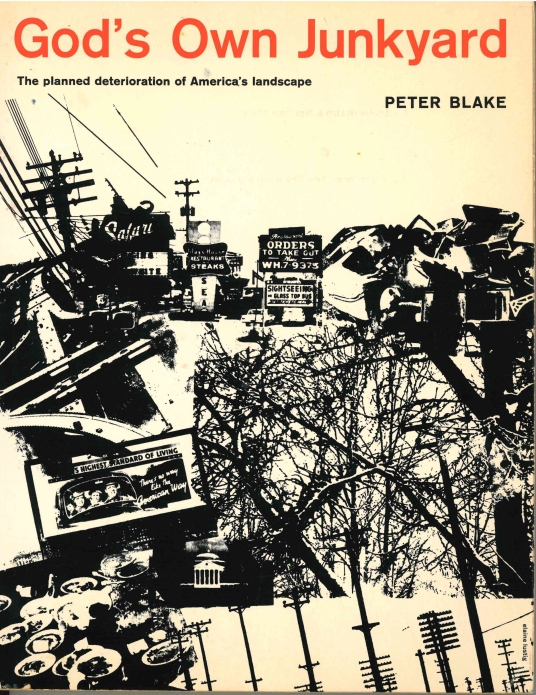
Figg.
5-6 - Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Learning From
Las Vegas, 1971, copertina. Tom Wolfe, Las Vegas (What?) Las Vegas
(Can’t heart you! Too Noisy), Esquire, February, 1964, pagina.97.

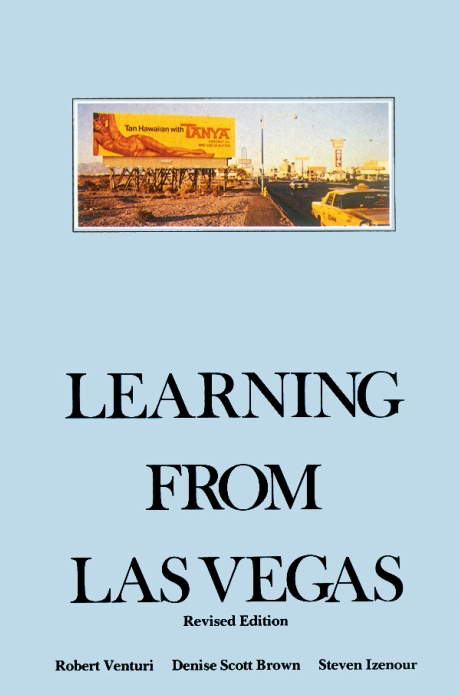
Das industriell entwickeltere Land zeigt dem minder
entwickelten nur das Bild der eignen Zukunft[1]. (Marx 1867)
L’attuale epoca dei consumi, caratterizzata dalla
globalizzazione, dallo smantellamento delle sicurezze e da una vita di
incertezze, sempre più frenetica e costretta ad adeguarsi
alle
attitudini del gruppo per non sentirsi esclusa, viene descritta da
Zygmunt Bauman, la Liquid modernity (2000).
Analogamente a
quanto pochi anni prima, Jean-François Lyotard, riconosceva
nella condizione postmoderna (1979) in entrambi i casi si indicava come
fatto saliente l’impossibilità di individuare
alcun centro
di riferimento.
All’opposto, più recentemente,
Richard Florida
(2003), afferma che i centri di riferimento di oggi sono molti e
coincidono con quei particolari luoghi capaci di attirare, stimolare e
incoraggiare le nuove e crescenti generazioni di creativi.
Paradossalmente però, questo articolo individua gli Stati
Uniti
d’America – il migliore dei mondi possibili (Rossi
2019)
– come centro di riferimento e modello per la cultura
capitalista, consumista e globale. Un modello che, come tale, anticipa
ciò che avverrà o sta avvenendo nel resto del
pianeta,
concordemente a quanto affermava Karl Marx alla fine del XIX secolo,
per cui «Il paese industrialmente più sviluppato
non fa
che mostrare a quello meno sviluppato l’immagine del proprio
avvenire» (Marx 1867, Prefazione).
Gli Stati Uniti come modello di riferimento culturale
dell’Occidente trovano conferma nella storia del Millennio
appena
concluso, soprattutto perché, come scrivono Stephen Gundle e
Marco Guani (1989), bisogna tenere in considerazione il fatto che
Nessun altro paese nel ventesimo secolo è stato in
grado di
competere con la crescente influenza e con l’ascendente che
gli
Stati Uniti hanno avuto sul mondo contemporaneo. Se pure si
può
argomentare che la potenza politica e militare americana raggiunse il
suo apice nel 1945, quando l’esclusività nel
possesso
della bomba atomica, la vittoria militare e una straordinaria
capacità economica e finanziaria produssero
un’egemonia
globale senza precedenti e senza seguito, per altri aspetti
l’importanza degli Stati Uniti nel mondo occidentale
è
probabilmente maggiore oggi che non quarant’anni fa.
(Gundle-Guani 1989)
Gli Stati Uniti, infatti, sono da tempo una solida e potente
Nazione
democratica, che ha conosciuto nel corso dell’ultimo secolo
un
enorme sviluppo economico tecnico-scientifico e culturale, ma
soprattutto è la Nazione che, con il suo intervento, ha
cambiato
le sorti di entrambi i conflitti mondiali.
Tuttavia, l’incontrastato sviluppo e diffusione
della cultura
americana non è dovuto al loro determinante intervento per
vincere entrambe le Guerre Mondiali; né tantomeno,
perché
non subirono nessun attacco nemico, tanto da poter mantenere in patria
tutte le attività ai vertici dello sviluppo; né
infine,
perché negli Stati Uniti emigrarono i più
importanti
esponenti in tutti i campi dello scibile umano per fuggire da
un’Europa funestata dalle persecuzioni naziste e dalle
dittature.
Le ragioni per cui gli Stati Uniti diventarono la potenza che
sono,
economica, scientifica e culturale, sono piuttosto da ricercare nella
continua profusione di ingenti energie e risorse per affermarsi come
modello di vita – la cosiddetta American way of
life – dal periodo della Cold War
(Orwell 1945)[2],
fino ad oggi.
Solo in parte, infatti, si conosce la diffusione
dell’American Way of Life come
l’esito di un’enorme impresa, compiuta dal 1947 al
1959
(Rossi 2019), la cui finalità fu quella di promuovere,
informare
e conquistare, con i mezzi della persuasione, della seduzione e del soft
power,
i Paesi devastati dalla Seconda Guerra Mondiale o quelli che ancora non
avevano scelto quale modello adottare – tra Comunista e
Capitalista – per la ripresa e la ricostruzione economica,
fisica
e morale.
Cosa si intende per soft power, lo
spiega Joseph S. Nye in una sua pubblicazione dal titolo significativo,
Bound to Lead. The Changing Nature of American Power
(1990): è la facoltà di realizzare obiettivi
prefissati
in materia di relazioni internazionali attraverso la seduzione
più che attraverso la coercizione (Mattelart, 2000).
La diffusione e conquista culturale mondiale degli Stati Uniti
viene
pienamente percepita nel periodo della ripresa e del boom economico
degli anni Sessanta-Settanta, quando gli effetti delle politiche
dell’European Recovery Program (ERP) e
dell’Organization for European Economic Cooperation
(OEEC) – il cosiddetto Marshall Plan
(1948-1952) – si fecero evidenti.
Come conseguenza delle politiche ERP-OEEC e delle strategie
del Soft Power,
dalla fine degli anni Cinquanta, frigoriferi, forni elettrici,
lavatrici, lavastoviglie, apparecchi radiofonici, televisori, film,
frullatori, aspirapolvere, supermercati, drive-in, fumetti, cartoni,
Jeans, Coca-Cola, Pepsi-Cola, fast food – oggetti comunemente
in
uso negli Stati Uniti fin dagli Anni Trenta – divennero
disponibili. Così, l’American Way of Life,
garantendo prosperità e libertà, si diffuse e
conquistò il Mondo.
Il fascino e la seduzione delle merci degli Stati Uniti
cambiarono
radicalmente il modo di vivere degli europei e dei Paesi impegnati nel
processo di ricostruzione e ripresa economica. Le merci, i beni, le
diverse modalità per cucinare, conseguenti
all’utilizzo
del microwave, del freezer
e dei cibi congelati,
così come l’utilizzo degli elettrodomestici,
contribuirono
a modificare il modo di vivere e, così pure,
l’architettura e le città.
Questa invasione di prodotti e la colonizzazione culturale
degli
Stati Uniti portò tuttavia molti Paesi, sottoposti a questo
fenomeno, a sentirsi minacciati, originando così il timore
dell’avvento di una società unica e una cultura
omologa
– internazionale e multinazionale prima, planetaria e globale
poi
– e del «diffondersi sotto i nostri occhi di una
civiltà mediocre e di una cultura elementare e
semplificata» (Ricoeur, cit. in Frampton 1982, p. 371),
fondata
sul consumo di massa. Tali timori trovarono espressione, soprattutto
dagli Anni Sessanta, nelle riflessioni di Paul Ricoeur (1961), Jean
Baudrillard (1968, 1970, 1986), Gilles Deleuze, Felix Guattari
(Deleuze-Guattari, 1972), Armand Mattelart (Dorfman-Mattelart 1972,
Mattelart 2001) e di molta della intelligentia
del tempo.
Venne così emergendo una vera e propria avversione e
contrapposizione tra la “cultura” del vecchio
continente, e
l’“incultura” del nuovo mondo; tuttavia,
Al di fuori degli Stati Uniti la gente probabilmente non
berrebbe
Coca-cola piuttosto che una qualsiasi altra bevanda frizzante, non
indosserebbe i Levi’s invece di altri calzoni pesanti di
cotone,
né mangerebbe gli hamburgers al posto di altri spuntini (non
almeno in tali grandi quantità) se non associasse tutte
queste
cose ad uno stile di vita attraente. (Gundle-Guani 1986, p. 562)
Di fatto, già dopo il primo conflitto mondiale,
l’idea
che l’Europa fosse la guida culturale e centro del mondo era
oramai superata.
Mentre nel 1919 Paul Valéry scriveva:
Tutto è arrivato in Europa e tutto è venuto da
essa. O
quasi tutto. Tuttavia, l’oggi implica questa domanda
cruciale:
l’Europa manterrà la sua preminenza in tutti i
generi?
L’Europa diventerà ciò che è
veramente,
ovvero: un piccolo capo del continente asiatico? O l’Europa
rimarrà ciò che sembra, cioè la parte
preziosa
dell’universo terrestre, la perla della sfera, il cervello di
un
vasto corpo?
il filosofo tedesco Oswald Spengler aveva inaugurato la breve
era di
pace, successiva al primo conflitto mondiale, con la pubblicazione de Il
tramonto dell’Occidente (1918),
in cui prefigurava la fine dell’Europa come centro della
civiltà occidentale, causata non solo dalla massificazione e
dalla perdita delle identità – in cui
all’individuo
si sostituisce la massa – ma anche e soprattutto
perché
entrava in crisi la sua supremazia economica, culturale e militare.
L’Europa, infatti, non aveva più la forza di
comandare il
mondo e inoltre, era il resto del mondo che non voleva più
essere comandato dall’Europa (Mattelart 2000).
Sarà soprattutto la politica punitiva dei trattati
di
Versailles – che umiliando la Germania e riducendo
l’Austria, da importante centro politico di un impero
multietnico
e poliglotta, ad una piccola Nazione – a suscitare e
fomentare
sentimenti di rivincita e risentimento, sviluppando politiche
nazionaliste, neutralizzeranno così ogni speranza per
l’unità politica e per il presunto primato
culturale
Europeo.
José Ortega y Gasset nel suo libro, La
rebelión de las masas (1930),
non accettava il tramonto dell’Europa pronosticato dallo
Spengler
e, inoltre, era in disaccordo con chi affermava che
l’avvenire
della civiltà sarebbe stata consegnata
all’America,
negandole la capacità di ereditare il ruolo di faro
spirituale
del mondo.
Tuttavia, la storia darà ragione proprio a Paul
Valéry, il quale affermava che in caso di deflagrazione
mondiale, l’unica nazione in grado di preservare la cultura
occidentale sarebbe stata proprio l’America, «la
più
favolosa creazione dello spirito europeo» (Mattelart 2000, p.
225).
Storiograficamente, la cultura americana è stata
considerata
come dipendente e discendente della cultura delle Nazioni
colonizzatrici che dominarono il Nuovo Mondo. Una visione condizionata
dalla storiografia occidentale, la quale aveva eletto
l’Europa
come centro di riferimento in rapporto al quale veniva costruita la
storia dell’intera umanità. In tale direzione,
anche la
cultura architettonica americana ha subito questo destino.
La progettazione urbana dei primi insediamenti in America
assunse un
ruolo determinante per la stabilizzazione degli imperi coloniali delle
potenze europee in lotta per la conquista del Nuovo Mondo (Reps 1965);
inoltre, il Nuovo Mondo fu anche il luogo per sperimentare e attuare le
utopie socialiste (Cabet 1840) e millenariste (Kruft 1989) degli
europei. Così, se l’origine
dell’architettura e
delle città americane discendevano
dall’applicazione dei
modelli dei colonizzatori europei (Reps 1965), l’architettura
moderna americana fu originata dalla
“colonizzazione” dei
maestri europei, grazie alla presenza e all’impulso di coloro
che, negli anni Trenta, emigrarono negli Stati Uniti per fuggire dalle
dittature e dalle persecuzioni razziali in atto in quegli anni in Europa[3].
A parte la breve parentesi dei grattacieli, delle grandi
costruzioni
industriali e delle infrastrutture – tanto decantate da Loos
(1921), Le Corbusier (1923, 1937) e Mendelshon (1926) – a
lungo
si è pensato che, come la cultura, anche
l’architettura
americana fosse condizionata, originata e dipendente da quella europea.
Infatti, come notarono Peter Blake (1993, 1996)[4]
e Tom Wolfe (1981), finita la Seconda Guerra Mondiale gli istituti
universitari e le scuole di architettura in America si adeguarono ai
principi di Mies, di Gropius e della Bauhaus.
Mentre, prima dell’arrivo dei maestri europei, le
Scuole
“moderne” in America non erano più di
due – la
Taliesin di Frank Lloyd Wright e la Cranbrook di Eliel Saarinen
(trasferitosi negli Stati Uniti nel 1923) – negli anni
Quaranta
lo erano diventate pressoché tutte. Il sistema
d’insegnamento americano – precedente
all’arrivo dei
maestri europei – che era ispirato all’Ecole
des Beaux-Arts,
sembrava non esistere più e chi l’aveva sostenuto
seguiva
allora tutt’altri orientamenti (Blake 1993, p. 44).
Mies van der Rohe giunse negli Stati Uniti nel 1937, grazie ad
un
invito del giovane Philipp Johnson, per costruire una country-house per
Stanley Resor in Jackson Hole, Wyoming e nel 1938 si stabilì
definitivamente in America, accettando l’invito di John
Holabird
di diventare il direttore della School of Architecture
all’Armour
Institute di Chicago (successivamente, Illinois Institute of
Technology).
Walter Gropius dopo l’allontanamento dal Bauhaus, a
causa
delle sue simpatie politiche di sinistra, riparò a Londra,
dove
lavorò con Maxwell Fry dal 1934 al 1937. Nel 1937 venne
invitato
negli Stati Uniti presso la Graduate School of Design ad Harvard, dove
diventò direttore della sezione di architettura dal 1937 al
1952. Nel 1937 venne inoltre invitato dal MoMA per organizzare la
mostra Bauhaus: 1919-1928[5].
L’eredità del Bauhaus trovò
particolare ospitalità presso il Black Mountain
Institute, fondato nel 1933 nel North Carolina, dove
lavorarono come professori Josef e Annie Albers, e lo stesso Gropius
(Harris 1987).
Herbert Bayer, direttore della sezione di stampa e grafica
presso la
Bauhaus, emigrò negli Stati Uniti nel 1938, dove venne
invitato
da Alfred H. Barr, Jr. – direttore del MoMA – ad
applicare
le sue teorie sull’esposizione e l’installazione
museografica nelle mostre del MoMA Bauhaus: 1919–28,
Road to Victory e Airways to Peace[6].
Nel 1932 il MoMA di New York aveva organizzato la mostra The
Modern Architecture: International Exhibition[7],
curata da Henry-Russel Hitchcock, Philip Johnson, Alfred H. Barr e
Lewis Mumford con cui si documentò la nascita e lo sviluppo
dello stile moderno, che da quel momento divenne
“International
Style” (Hitchcock-Johnson 1932). Una mostra che
più di
ogni altra iniziativa aveva promosso il Movimento Moderno (soprattutto
europeo) in America (Riley 1992). È da questa situazione che
l’International Style divenne il “nuovo stile
americano”, come hanno sottolineato Tom Wolfe (1981) e Peter
Blake (1996).
A quel tempo, le pubblicazioni più importanti
avevano il
proposito “didattico” di avvicinare il pubblico e
gli
architetti al “nuovo stile”, come The
International Style: Architecture since 1922 (Hitchcock-Johnson
1932); An Introduction to Modern Architecture
(Richards, 1940); What is Modern Architecture?
(Bauer Mock-McAndrew 1942), o ancora, di testimoniarne la diffusione
come in An outline of European architecture (Pevsner
1943); Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries
Modern Architecture (Hitchcock 1958), infine, di
presentarne i maestri come in Pioneers of the Modern
Movement, from William Morris to Walter Gropius (Pevsner
1936).
Queste pubblicazioni e storie dell’architettura
dedicarono poco spazio all’America e ancor meno ai suoi
maestri.
Henry Hobson Richardson, Henry Louis Sullivan, Frank Lloyd
Wright
erano parte di capitoli marginali, tra Romantico, Art Nouveau e
proto-moderno. Come affermò Lewis Mumford nel suo The
Brown Decades
(1931), «Non disponiamo ancora di una approfondita,
autentica,
intelligente storia dell’architettura americana»
(Mumford
1977, p. 166).
Con la pubblicazione di Verso
un’architettura Organica del 1945 e la successiva Storia
dell’architettura moderna
del 1950 di Bruno Zevi, si ha testimonianza di un primo originale
accostamento ed esaustivo studio dell’architettura e dei
maestri
americani.
Per la prima volta, nella storia dell’architettura,
le figure
e il pensiero architettonico americano assunsero un ruolo determinante
e paradigmatico per osservare e interpretare lo sviluppo
dell’architettura moderna.
Come scrisse Zevi (1945),
Storie dell’architettura moderna sono uscite in gran
numero
negli ultimi anni in America e in Inghilterra ed alcune di esse sono
eccellenti. Ma in generale queste storie si chiudono dopo aver trattato
della prima generazione di architetti moderni, dei maggiori maestri che
lavorarono, specie in Germania e in Francia […] Il mio
proposito
è invece di ricercare una direttiva
nell’architettura
degli anni più recenti; più che di storia, si
tratta
perciò di cronaca, ma pare evidente che in essa
già possa
scorgersi un atteggiamento intellettuale e artistico verso
l’architettura degno di essere esposto. I migliori architetti
contemporanei vanno verso un genere di architettura cui qui si
è
dato il nome di organico. (Zevi 1945, pp. 11-12)
Il significato di organico, nel libro di Zevi (1945, pp.
63-64), viene mutuato dalle parole di William Lescaze:
Organico è la parola che F. L. adopera per
descrivere la sua
architettura […] L’aggettivo fu per la prima volta
applicato all’architettura da Louis Sullivan […].
Secondo
quanto Claude Bragdon […] spiegò […],
l’architettura mondiale nella sua storia presenta un
inevitabile
dualismo, perché è stata o organica
(cioè che ha
seguito la legge degli organismi naturali) o predisposta (composta
secondo qualche ideale euclideo inventato dall’uomo).
(Lescaze
1942, pp. 78-79)
Con Zevi, Wright e la poetica Organica degli architetti della
Bay
Region, di Aalto e dell’Empirismo Scandinavo, diventarono i
punti
di riferimento dell’architettura Moderna; non più
il
macchinismo di Giedion e Gropius, dei CIAM e di Le Corbusier.
L’America fu per Zevi, l’epicentro culturale, il
paese,
capace di proporre un’alternativa ai presupposti scientifici,
ai
regolamenti dell’Existenzminimum e dei
CIAM[8].
Oltre al punto di vista di Zevi, Blake, nel suo The
Master Builders (Blake
1960), ebbe addirittura il “coraggio” di accostare
Frank
Lloyd Wright a Mies e Le Corbusier, affermando che nessun edificio
moderno costruito oggi avrebbe l’aspetto che ha se non fosse
per
le opere di questi tre maestri (Blake 1960, pp. 17-18).
Tuttavia, la cultura architettonica americana ancora stentava
a
definirsi come indipendente e ad emanciparsi da quella europea, come
testimonia l’importante mostra del MoMA, Modern
Architecture U.S.A. del 1965[9].
La mostra, curata dal direttore del dipartimento di
architettura e
design del MoMA, Arthur Drexler, succeduto a Philip Johnson nel 1956,
era dedicata ai contributi degli architetti
“americani” al
Movimento Moderno, ma, a parte il lavoro di Frank Lloyd Wright, Greene
& Greene e Irvin Gill, la maggior parte degli architetti
selezionati per rappresentare l’architettura moderna
americana
erano gli stranieri emigrati negli USA. Un altro aspetto
“debole” della mostra era la completa esclusione
delle
“autentiche” conquiste dell’architettura
americana;
le stazioni ferroviarie, i grattacieli, i Bowling Alleys, i Mall, i
Drive-in e i Motel... Questo fu quanto fece notare Reyner Banham (1965)
in un articolo dedicato alla mostra.
Banham considerava riduttiva la scelta di Drexler di
presentare un repertorio di pietre miliari della modernità International
Style,
ignorando, al contrario, l’architettura più
rappresentativa degli Stati Uniti; quella più
“popolare” e visibile, on the road,
a cui, fin
dal 1932, Frank Lloyd Wright ne riconosceva il ruolo centrale per la
costruzione delle “nuove” città:
La stazione di rifornimento delle rotabili può
essere in
embrione il futuro centro distributivo della città. Ogni
stazione può benissimo svilupparsi in un ben progettato,
conveniente centro di distribuzione di zona che diverrà, del
tutto naturalmente, un luogo di convegno, un ristorante, una sala di
riposo o qualsiasi altra cosa possa rendersi necessaria col progredire
e l’affermarsi del decentramento e della reintegrazione.
Già centinaia di migliaia di queste stazioni di rifornimento
hanno occupato i punti migliori nelle cittadine o, cosa anche
più importante, a notevole distanza dai centri abitati.
(Wright,
2016, p. 293)
L’opinione di Drexler, era che certamente Motels,
Supermarkets, Bowling Alleys, Oil stations, Hamburger Stands erano
architetture diffuse e popolari negli USA, ma di certo, non erano le
più rappresentative e degne di essere esposte al MoMA;
d’altra parte, il museo aveva sempre e solo dato spazio
all’architettura “alta” e
“colta”.
Come testimonia Peter Blake nella conferenza di Melbourne
(Blake
1971), egli era, come molti altri, del parere che non esistesse
«Paese più volgare e banale degli Stati Uniti: gli
Stati
Uniti di Las Vegas e di Los Angeles, dei sordidi chioschi sparsi lungo
le autostrade, della pubblicità» (Blake 1973, p.
55).
Anch’egli, come Drexler, deplorava la
volgarità e
l’inquinamento visivo che deturpavano il paesaggio, le strade
e
le città americane – e nel 1963 aveva pure scritto
un
libro su questo argomento, God’s own junkyard
(Blake 1963) – tuttavia, a Melbourne, affermò che
i tipi come me andavano in giro a fare conferenze contro
questo
genere di cose, concludendo che un Paese capace di produrre una
quantità così pazzesca di spazzatura non valeva
la pena
di essere salvato (Blake 1973, p. 55).
Ma dovette cambiare idea. Nonostante tutto, bisognava
ammettere che
il fenomeno più interessante degli ultimi dieci o
vent’anni nel campo delle arti […] sia stato la
nascita
della Pop Art – o meglio l’aver scoperto in
ciò che
una volta consideravamo futile e volgare una enorme risorsa inesplorata
(Blake 1973, p. 55).
In ogni caso, prima di poter percepire un cambiamento
sostanziale
tra le storie dell’architettura con un punto di vista
“europeo” e uno “americano”,
bisognerà
aspettare le pubblicazioni dello storico dell’architettura
americano Vincent Scully Jr. (1961, 1969).
La sua prima storia dell’architettura,
Modern Architecture (Scully, 1961), fu un primo passo, ma
con American Architecture and Urbanism (1969),
Scully affrontò l’architettura americana dalla
preistoria, osservando quanto essa influì sui Conquistadores,
come nel caso delle chiese di San Esteban ad Acona, del 1630 circa, o
San Francisco a Rachos de Taos del 1772, nel New Messico.
In American Architecture Scully
studiò i tratti di
originalità della cultura architettonica americana,
stabilendone
l’indipendenza da quella europea, individuando e distinguendo
ciò che era “americano” da
ciò che era
“europeo”. Se tutto questo non bastasse,
nell’introduzione di Complexity and Contradiction
in Architecture
di Robert Venturi (1966, p. 6), Scully definì il libro di
Venturi come il più importante testo di architettura del
Novecento dopo Vers une Architecture di Le
Corbusier (1923).
Furono infine, proprio Robert Venturi, Denise Scott Brown e
Steven Izenour, che con Learning From Las Vegas
(1972), contestarono la differenza tra cultura colta e cultura volgare,
rivendicando la legittimità di poter amare al contempo il
manierismo italiano e l’architettura vernacolare americana
come
espressioni autentiche di una cultura e di una civiltà,
opponendosi così alle concezioni elitarie espresse pochi
anni
prima da Blake e Drexler.
Quanto scrissero Tom Wolf in Las Vegas. What?
Las Vegas Can’t heart you! Too Noisy (1964)
e Rayner Banham in Towards a million-volt light and sound
culture
(1967), chiarisce quanto il clima culturale fosse cambiato. Secondo
loro Versailles e Las Vegas erano l’autentico modello della
città moderna della storia occidentale e così,
quanto
diedero avvio la Scott Brown Izenour e Venturi con i loro studenti, non
fu solo lo studio della singola città di Las Vegas, ma di
tutte
le città del mondo che, prima o poi, si sarebbero sviluppate
in
funzione dell’automobile, della pubblicità, degli
Shopping
Centers, dei Fast Food, delle Gas Stations, così
meravigliosamente progettate, descritte, studiate e testimoniate da
Wright (1932), Rusha (1963), Wolfe (1964), Banham (1971), Scott Brown,
Izenour, Venturi (1972), Blake (1963) e molti altri.
La rivendicazione di indipendenza, il taglio del cordone
ombelicale
dell’architettura americana da quella europea, era
definitivamente sancito.
L’America aveva i suoi pionieri, i suoi eroi, i suoi
maestri,
i suoi poeti, le sue scuole, la propria storia e infine, la propria
tradizione (Wrenn-Mulloy, 1976).
Passati appena quarant’anni da queste prime
manifestazioni di
consapevolezza e indipendenza culturale, nel 2014, diversamente dalla
mostra del MoMA Modern Architecture U.S.A. del
1965, in occasione della XIV mostra internazionale di
Architettura della Biennale di Venezia,
nel padiglione degli Stati Uniti si dava
“dimostrazione”
della diffusione dell’architettura americana nel mondo in tre
cataloghi.
Il primo, OfficeUS Atlas – di
ben 1230 pagine –
(Gilabert-Kubo,-Miljački-Schafer 2014) consiste di un’ampia
ed
esaustiva selezione di articoli d’epoca, a testimonianza dei
lavori degli architetti americani overseas; di
articoli e saggi sulla struttura organizzativa (business
management) degli studi americani; di una serie di schede
sugli architetti nazionali, e molto altro. Il secondo catalogo, OfficeUS
Agenda (Gilabert-Lawrence-Miljački-Schafer
2014), contiene saggi sulle “competenze
manageriali” degli
architetti americani; sulla cooperazione internazionale compiuta dagli
architetti degli Stati Uniti in terra straniera[10] e sul ruolo
dell’architettura americana come ambasciatrice
dell’America nel mondo.
Nell’ultimo catalogo della mostra, OfficeUS
Manual
(Gilabert-Miljački-Carrasico-Reidel-Schafer 2014), si mostrano al mondo
le “buone pratiche” degli studi americani per
ottenere
successo; un vero e proprio manuale di business management
per gli architetti.
Fu così che nell’esposizione della
XIV mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia,
il visitatore del padiglione USA veniva letteralmente investito
dall’enorme quantità di progetti che gli
architetti
americani avevano realizzato in ogni dove. Una vera e propria
rivelazione.
Tuttavia, la percezione e consapevolezza che
l’architettura
americana, così come il primato in ogni altro campo, fosse
già un fenomeno globale, non necessitava di alcuna
dimostrazione.
Come affermava Armand Mattelart (2000),
l’unico paese
che, per il suo potere d’influenza, meritava il nome di
“società globale” erano proprio gli
Stati Uniti. Per
maturità, la società americana era la
società che
illuminava il cammino delle altre nazioni. In termini politici ormai,
non si poteva più parlare di “imperialismo
culturale” degli Stati Uniti nei confronti del resto del
mondo
per il fatto che la loro industria culturale e i loro modelli di
organizzazione erano di per sé universali. Quello che gli
Stati
Uniti proponevano era un modello globale di modernità, un
modello di comportamento e di valori destinato ad essere imitato su
tutto il pianeta. Cosicché, Mattelart, prospettava la nuova
società globale come un’estrapolazione
dell’archetipo nato e cresciuto nel Nuovo Mondo.
Nel campo architettonico è sufficiente considerare
quanto si
è diffusa la pratica costruttiva del grattacielo. In
origine,
autentico archetipo americano e costruzione esclusivamente americana
– gli unici esempi di edifici alti, prima del 1920, erano
visibili solo a New York e Chicago – oggi i grattacieli sono
le
“nuove” costruzioni più diffuse nel
pianeta.
Il grande successo del grattacielo deriva essenzialmente dalla
sua
simultanea rappresentatività di modernità,
simbolicità e di Reklame Arkitectur (Hilberseimer 1927),
poiché «The Medium is the Massage»
(McLuhan 1967).
Questo fenomeno però non ha nel grattacielo
l’unico
protagonista. L’enorme successo delle catene di alberghi, di
abbigliamento, di Fast Food, di Supermercati, di centri commerciali, di
sedi per uffici delle multinazionali – altri edifici
“originariamente” americani – sono
anch’essi
oggi globalmente diffusi, facendo registrare così la loro
crescente adozione in contesti geografici molto differenti e favorendo
soprattutto, la formazione di paesaggi urbani che vanno via via negando
le loro originarie peculiarità e contribuendo alla
formazione di
luoghi che il sociologo francese Marc Augé ha definito Non-Lieux
[non
luoghi](1992); costruzioni elette per rappresentare le
società
moderne o in via di sviluppo, soprattutto per la loro attitudine
atopica, per le loro doti di essere ripetute – di poter
trasmigrare – in qualsiasi parte del mondo senza eccezioni.
Fenomeno questo, rasserenante e al contempo alienante. Rasserenante
perché protegge dal “rischio” della
“sorpresa” di contesti ambientali
“diversi” e
“sconosciuti”; alienante perché luogo
universale,
ovunque uguale.
Nel corso dei primi anni di questo terzo millennio, si
registra la
crescente realizzazione di edifici con il deliberato ricorso tanto a
eccezionali e ardite soluzioni costruttive, quanto a sofisticate
tecniche che le rendono possibili, e che consentono di creare contesti
ambientali esplicitamente artificiali e svincolati dalle condizionanti
situazioni locali.
Alle attuali linee della ricerca progettuale ed al tipo di
tecnica
che le rende attuabili, sembra essere sottesa la convinzione che i
modelli edilizi non debbano necessariamente essere radicati ai contesti
locali (e questo è ciò che si è
apprezzato, il
pregio che ne ha decretato il grande successo e diffusione globale),
così che, è venuto a mancare il legame con le
realtà locali.
A partire dagli anni Cinquanta e con crescente
intensità,
negli Stati Uniti si moltiplicarono interventi edilizi caratterizzati
da opere ad altissimo tenore tecnologico. Oltre ai già
citati
grattacieli, nei laboratori del MIT si svilupparono studi e prototipi
per case ad energia solare (Barber 2014, 2016) e case prefabbricate e
componibili di plastica (Behrendt 1958; Plastic Houses 1956),
successivamente – presso il Media Lab del MIT – con
lo
straordinario sviluppo delle tecnologie digitali,
dell’Intelligenza Artificiale e della domotica, si
poté
pensare alle case autosufficienti e alle Città
dei Bits: le Smart Cities (Mitchell
1995).
Si è notato (McLuhan 1962) che
l’alfabetizzazione
mediatica su scala planetaria ponesse le premesse della
globalizzazione, ma anche che la nuova interdipendenza elettronica
ricreava il mondo nell’immagine di quello che si poteva
definire
un villaggio globale (McLuhan 1962, p. 31).
Secondo McLuhan, le scoperte tecnotroniche hanno ricreato il
“campo”, per cui viviamo in un unico spazio
ristretto che
risuona di tamburi tribali. Così che, la preoccupazione per
il
“primitivo” oggi, risulta essere banale quanto la
preoccupazione per il “progresso” del XIX secolo e
irrilevante per i nostri problemi (McLuhan 1962, p. 31), egli afferma
che
Il nostro è un mondo nuovo di zecca tutto in una
volta. Il
“tempo” è cessato, lo
“spazio” è
svanito. Ora viviamo in un villaggio globale ... un accadimento
simultaneo. (McLuhan 1967, p. 63)
Tuttavia, questo modello globale di modernità
impone da una
parte la riflessione sul concetto stesso di sviluppo, e
dall’altra, sul problema delle istanze culturali regionaliste
e
identitarie che Kenneth Frampton esponeva in Critical
Regionalism: modern architecture and cultural identity (Frampton
1980, pp. 313-327).
Da tempo, si sostiene che l’attuale processo di
sviluppo
– cosiddetto lineare – ha quasi esaurito e
dissipato le
risorse planetarie e che il fenomeno della globalizzazione ha messo a
repentaglio, se non annientato, le diversità e le
complessità culturali delle Nazioni e dei Paesi del mondo.
Ma,
se la prima affermazione può corrispondere al vero, la
seconda
è ancora tutta da dimostrare. Paradossalmente, la
globalizzazione è un fenomeno che ha dato forza propulsiva
alle
istanze identitarie, in atto da decenni, ed è altrettanto
evidente, che ai problemi dell’esaurimento delle risorse e
della
relativa emergenza planetaria, corrispondono le crescenti azioni
contrarie, di compensazione e resilienza, di cui il Critical
Regionalism è portatore.
Oggi per tanto, ci si chiede se il modello di sviluppo degli
Stati
Uniti e di tutto quel mondo che ad essi guardano, può essere
replicato; in altre parole, possono i Paesi meno sviluppati –
come diceva Marx – seguire le orme di sviluppo degli Stati
Uniti
d’America? Un Paese dalle vaste dimensioni, dalle illimitate
(si
pensava) risorse minerarie e dagli immensi giacimenti di petrolio? Un
Paese dell’abbondanza, proiettato verso il futuro e dal
grande
avvenire, dove tutto è possibile?
La risposta è, a questo punto, scontata, e la
domanda
retorica. Ovviamente, le possibilità di sviluppo non possono
essere più e per nessuno, quelle che hanno reso possibile
l’indiscutibile primato degli Stati Uniti. La parentesi
storica
dello sviluppo lineare e del consumismo, di cui gli Stati Uniti hanno
rappresentato il modello (Galbraith, 1958), non è
più, da
molto tempo, sostenibile, oltre che per ragioni etiche, per le
necessità di preservare l’equilibrio,
già sconvolto
e quasi [?][11]
irreversibilmente compromesso del Pianeta (Schumacher 1973).
Tuttavia, oggi, le costruzioni più diffuse al mondo
sono
proprio i grattacieli, i centri commerciali e ad esse si associano le
salvifiche Smart Cities, assunte come modello per
un nuovo
equilibrio tra città, società e Pianeta. Modelli
originati e sviluppati negli Stati Uniti e, con il tempo, assimilati e
diffusi in tutto il mondo, così che, come affermava
Mattelart
(2000), la società globale altro non è che
l’estrapolazione dell’archetipo nato e cresciuto
nel Nuovo
Mondo.
Ma questi edifici, così come le Smart
Cities,
adottati come modello globale, richiedono enormi quantità di
energia, un elevato apparato informatico, tecnologico e scientifico.
Tutto questo porta alla paradossale, ridicola, se non tragica
situazione per cui nel mondo, Paesi meno sviluppati utilizzino questi
modelli incondizionatamente, conducendo a quanto Richard Sennett
osservava e che induce all’ovvia domanda in termini di
progettazione, di come sia possibile che un paese come
l’India,
con una popolazione che non ha acqua potabile, nessun sistema fognario
e nessun ambulatorio a livello di quartiere, cerchi di seguire questa
strada destinata al fallimento, progettando 100 Smart Cities
nuove di zecca (Sennett 2018, p. 162).
Evidentemente, l’inerzia con cui i Paesi
sottosviluppati, o
semplicemente meno sviluppati degli Stati Uniti, vogliano
anch’essi raggiungere le vette dello sviluppo è
ancora
questione aperta. Purtroppo, però, il modello lineare, e lo
sviluppo economico globale – modello adottato da tutti i
Paesi,
industrializzati e non – ha sprecato e consumato le risorse
e,
soprattutto, ha prodotto una quantità indescrivibile di
rifiuti,
nonché causato l’annullamento delle
diversità
culturali, regionali e locali.
In tal senso la cultura del Regionalismo Critico
e di tutti
coloro che percepirono come una grande illusione la
possibilità
di uno sviluppo continuo e illimitato, oggi troveranno una rinnovata,
forse necessaria, collocazione.
Per contrastare l’attuale modello di sviluppo, forse
non basteranno il Regionalismo Critico
e la ricerca di un modello di consumo circolare e di piccola produzione
– regionale – come proposto da Ernst Friedrich
Schumacher
(1973); ma sarà molto probabile che i diversi Paesi del
mondo
dovranno necessariamente formulare dei modelli di ripensamento
–
critico – nei confronti di quelli attuali, seguendo ognuno,
le
proprie attitudini, possibilità e cultura locale –
regionale?
Come afferma Frampton,
Il regionalismo critico tende a prosperare in quegli
interstizi
culturali che, in un modo o nell’altro, sono in grado di
sfuggire
alla tensione ottimizzante della civiltà universale. La sua
comparsa indica che la nozione ereditata di un centro culturale
dominante circondato da satelliti dipendenti e dominati è,
in
ultima analisi, un modello inadeguato per dare un giudizio complessivo
sullo stato attuale dell’architettura moderna. (Frampton
1982, p.
387)
Questo ci rassicurerebbe e farebbe piacere crederlo.
Note
[1]
Il paese industrialmente
più sviluppato non fa che mostrare a quello meno sviluppato
l’immagine del proprio avvenire.
[2]
Generalmente l’inizio della Cold War
viene cronologicamente collocato nel 1947 con l’adozione del National
Security Act
(18 settembre, 1947) e si conclude simbolicamente con la caduta del
muro di Berlino (1989) e lo scioglimento dell’URSS (1991).
Diversamente qui si indica come data di inizio della Cold War
il 1945, in concomitanza dello scritto di George Orwell che, in
risposta al bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaky, scrive
l’articolo “You and the Atomic Bomb”
(1945):
«The atomic bomb may complete the process by robbing the
exploited classes and peoples of all power to revolt, and at the same
time putting the possessors of the bomb on a basis of military
equality. Unable to conquer one another, they are likely to continue
ruling the world between them, and it is difficult to see how the
balance can be upset except by slow and unpredictable demographic
changes […] that is, the kind of world-view, the kind of
beliefs, and the social structure that would probably prevail in a
state which was at once unconquerable and in a permanent state of
“cold war” with its neighbours».
[3]
Negli USA infatti
emigrarono Theodor W. Adorno (1939), Josef and Annie Albers (1933),
Herbert Bayer (1938), Peter Blake (1940), Max Beckmann (1933), Marcel
Breuer (1937), Serge Chermayeff (1940), Albert Einstein (1938), Enrico
Fermi (1938), Walter Gropius (1937), George Grosz (1933), Victor Gruen
(1938), Max Horkheimer (1933), Fritz Lang (1934), Claude
Lévi-Strauss (1940), Peter Lorre (1935), Thomas Mann (1939),
Erich Mendelsohn (1941), László Moholy-Nagy
(1937), Sibyl
Moholy-Nagy (1937), Piet Mondrian (1940), Mies van der Rohe (1933),
Berta and Bernard Rudofsky (1941), Josep Lluís Sert (1939),
Hans
Richter (1940), Arnold Schoenberg (1933), Georg and Maria Ludwig von
Trapp (1938), Oskar Wlach (1940), Bruno Zevi (1940) e molti altri (la
data indica l’anno di arrivo negli USA).
[4]
Le osservazioni di Peter
Blake riguardo l’influsso dei maestri europei emigrati negli
Stati Uniti, appartengono a pubblicazioni piuttosto recenti, ma queste,
come è testimoniato in No Place Like Utopia
(Blake, 1993), risalgono ai primi anni Cinquanta.
[5]
Bauhaus: 1919-1928 [MoMA Exhibition. #82, December
7, 1938-January 30, 1939].
[6]
Road to Victory [MoMA Exhibition #182, May
21-October 4, 1942], Airways to Peace [MoMA
Exhibition #236, July 2-October 31, 1943].
[7]
Modern Architecture: International Exhibition
[MoMA Exh. #15, February 9-March 23, 1932]
[8]
Non bisogna dimenticare che
Zevi a seguito delle leggi razziali, lascia l’Italia nel 1939
per
recarsi prima a Londra e poi, nel 1940, negli Stati Uniti. Qui si
laurea presso la Graduate School of Design della Harvard University,
diretta da Walter Gropius, e scopre Frank Lloyd Wright. Nel 1943 torna
in Europa a bordo di una nave militare che approda a Glasgow, vive da
rifugiato a Londra e, su incarico dell’esercito degli Stati
Uniti, progetta accampamenti militari prefabbricati in vista dello
sbarco in Normandia. A Londra frequenta la biblioteca del RIBA e
prepara la stesura del suo primo libro, Verso
un’architettura organica.
[9]
Modern Architecture, U.S.A. [MoMA Exhibition
#767a, May 18-September 6, 1965].
[10]
Emblematico il lavoro
compiuto da Albert Kahn, l’architetto di Ford (Bucci, 1992),
per
l’edificazione di complessi industriali in Russia.
[11]
Il punto di domanda sta
ad indicare l’incertezza di questa affermazione. Ancora non
sappiamo se abbiamo sconvolto l’equilibrio del pianeta in
modo
irreversibile o se siamo in tempo per invertire i processi innescati
dalla deforestazione, dall’inquinamento dell’aria,
dell’acqua…cause dell’effetto serra, dei
Tornado,
dell’innalzamento del livello del mare, dello scioglimento
dei
ghiacciai……e delle pandemie.
Bibliografia
(1956) – “Plastic Houses: new form for a
new architecture”. The Canadian Architect, 10, 22-29.
AUGÉ M. (1992) – Non-Lieux.
Introduction à une anthropologie de la
surmodernité. Seuil, París.
BANHAM R. (1965) – “The Missing Motel:
Unrecognized American Architecture”. Landscape, 2.
BANHAM R. (1967) – “Towards a million-volt
light and sound culture”. The Architectural Review, 843,
(Maj).
BANHAM R. (1971) – Los Angeles: The
Architecture of Four Ecologies. Penguin Press, London.
BARBER A.D. (2014) – “Tomorrow’s
House: Solar Housing in 1940s America”.
Technology and Culture, 55, January.
BARBER A.D. (2016) – A House in the Sun.
Modern Architecture and Solar Energy in the Cold War. Oxford
University Press, New York.
BAUDRILLARD J. (1968) – Le
Système des objets. Gallimard, París.
BAUDRILLARD J. (1970) – Amérique.
Grasset, París.
BAUDRILLARD J. (1970a) – Société
de consummation. Gallimard, París.
BAUER MOCK E., McANDREW J. (1942) – What
is Modern Architecture? MoMA, New York.
BAUMAN Z. (2000) – Liquid modernity.
Polity Press, Cambridge.
BEHRENDT E. (1958) – “Plastic
House”. Popular Science, April, 144-147; 262.
BLAKE P. (1960) – The Master Builders; Le
Corbusier; Mies van der Rohe; Frank Lloyd Wright. Alfred A.
Knopf, New York.
BLAKE P. (1963) – God’s Own
Junkyard, The planned deterioration of American landscape.
Holt, New York.
BLAKE P. (1993) – No Place Like Utopia,
Alfred A. Knopf, New York.
BLAKE P. (1996) – “From Mies to Mickey
Mouse”. Zodiac 16.
BRZEZINSKI Z. (1969) – Between Two Ages.
America's Role in the Technetronic Era. Viking Press, New
York.
BUCCI F. (1992) – L’ architetto
di Ford. Albert Kahn e il progetto della fabbrica
moderna. Cittastudi, Milano.
CABET E. (1840) – Voyage en Icarie.
Bureau du Populaire, Paris.
DELEUZE G. e GUATTARI F. (1972) –
L’Anti-Oedipe. Les Editions de Minuit,
París.
DELEUZE G. e GUATTARI F. (1980) – Mille
Plateaux. Les Editions de Minuit, París.
DORFMAN A. e MATTELART A. (1971) – Para
Leer al Pato Donald. Ediciones Universitarias de
Valparaíso, Valparaíso.
FLORIDA R. (2003) – The Rise of the
Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure,
Community and Everyday Life. Basic Books, New York.
FRAMPTON K. (1980) – Modern Architecture:
a Critical History. Thames and Hudson, London.
FRAMPTON K. (1982) – Storia
dell’architettura moderna, Zanichelli, Bologna.
GALBRAITH J.K: (1958) – The Fluent Society.
Harcourt Publishing, New York.
GILABERT E. F., Kubo M., Miljački A., Schafer A. (eds.) (2014)
– OfficeUS Atlas. Lars Müller
Publishers, Zürich.
GILABERT E. F., Kubo M., Miljački A., Schafer A., Lawrence A.
R. (eds.) (2014) – OfficeUS Agenda.
Lars Müller Publishers, Zürich.
GILABERT E. F., Miljački A., Schafer A., Mínguez
Carrasco C., Reidel J. (eds.) (2014) – OfficeUS
Manual. Lars Müller Publishers, Zürich.
GUNDLE S., GUANI M. (agosto 1989) –
“L’americanizzazione del Quotidiano”.
Quaderni storici, 62.
HARRIS M. E. (1987) – The Arts at Black
Mountain College. MIT Press, Cambridge.
HILBERSEIMER L. (1927) – Groszstadt
Architektur. Julius Hoffmann, Stuttgart.
HITCHCOCK H.R. (1958) – Architecture:
Nineteenth and Twentieth Centuries Modern Architecture. Penguin
Books, Harmondsworth.
HITCHCOCK H.R., JOHNSON P. (1932) – The
International Style: Architecture since 1922, W.W. Norton
& company, inc., New York.
KRUFT H.W. (1989) – Städte in
Utopia. C.H.Beck, München.
LE CORBUSIER (1923) – Vers Une
Architecture. Éditions Crès,
París.
LE CORBUSIER (1937) – Quand les
cathédrales étaient blanches. Voyage au pays des
timides. Éditions Plon, París.
LESCAZE W. (1942) – On being an architect,
G.P. Putnam’s Sons, New York.
LYOTARD J-F. (1979) – La Condition
Postmoderne: Rapport Sur Le Savoir. Les Editions de minuit,
Paris.
LYOTARD J-F. (1981) – La Condizione
postmoderna. Rapporto sul sapere.
Feltrinelli, Milano.
MARX K. (1867) – Das Kapital.
Verlag von Otto Meissner, Hamburg; (1887) – Capital.
A Critique of Political Economy.
Progress Publishers, Moscow.
MATTELART A. (2000) – L’histoire
de l’utopie
planétaire. De la cité prophétique
à la
société globale. La
Découverte, Paris.
MATTELART A. (2001) – Histoire de la
societe de l’information. La Decouverte,
París.
McLUHAN M. (1962) – The Gutemberg Galaxy,
University of Toronto Press.
McLUHAN M. e FIORE Q. (1967) – The Medium
is the Massage. Penguin, London.
MENDELSHON E. (1926) – Amerika.
Bilderbuch eines Architekten. Mosse, Berlin.
MITCHEL W. J. (1995) – City of Bits.
Space, Place, and the Infobahn. MIT Press, Cambridge.
MUMFORD L. (1931) – The Brown Decades.
Harcourt Brace & Co. New York.
MUMFORD L. (1977) – Architettura e
cultura in America. Marsilio, Padova.
NYE J. S. (1990) – Bound to Lead. The
Changing Nature of American Power. Basic Books, New York.
ORTEGA Y GASSET J. (1930) – “La
rebelión de las
masas”. Ediciones de la Revista de Occidente. 39 noviembre.
ORWELL G. (1945) – “You and the Atomic
Bomb”, Tribune (October 14).
PEVSNER N. (1936) – Pioneers of the
Modern Movement, from William Morris to Walter Gropius.
Faber and Faber, Ltd. Price, London.
PEVSNER N. (1943) – An outline of
European architecture. Penguin, London.
REPS J.W. (1965) – Town Planning in
Frontier America. Princeton University Press, Princeton.
RICHARDS J.M. (1940) – An Introduction to
Modern Architecture. Pelican. London.
RICOEUR P. (1961) – “Universal
Civilization and National Cultures”. In: History
and Truth. Northwestern University Press, Evanston.
RILEY T. (1992)– The International Style:
Exhibition 15 and The Museum of Modern Art. Rizzoli, New
York.
ROSSI U. (2019) – “The Best of All
Possible Worlds. USA
1949–1959: God’s Own Country”. HPA,
Histories of
Postwar Architecture, 4.
RUSHA E. (1963) – Twentysix Gasoline
Stations. Los Angeles.
SCHUMACHER E.F. (1973) – Small is
Beautiful. A study of Economics as if People Mattered. Blond
& Briggs, London.
SENNETT R. (2018) – Building and
Dwelling, Ethics for the City. Farras Strauss &
Giroux, New York.
SERVAN-SCHREIBER J.J. (1980) – Le
défi Mondial. Fayard, Paris 1980.
SPENGLER O. (1918) – Der Untergang des
Abendlandes. Oskar Beck, Münich.
VALÉRY P. (1919) – “La Crise de
l’esprit”. La Nouvelle Revue Francaise, August.
VENTURI R. (1966) – Complexity and
Contradiction in Architecture. MoMA, New York.
VENTURI R., SCOTT BROWN D., IZENOUR S. (1972) – Learning
From Las Vegas. MIT, Cambridge.
WOLFE T. (1964) – “Las Vegas (What?) Las
Vegas (Can’t heart you! Too Noisy)”. Esquire,
February.
WOLFE T. (1981) – From Bauhaus to Our
House. Farrar, Straus & Giroux, New York.
WRENN T. P., MULLOY E. D. (1976) – America’s
Forgotten Architecture. Pantheon, New York.
WRIGHT F. L. (1932) – An Autobiography.
Faber & Faber, London.
WRIGHT F. L. (2016) – Una atobiografia.
Jaka Book, Milano.