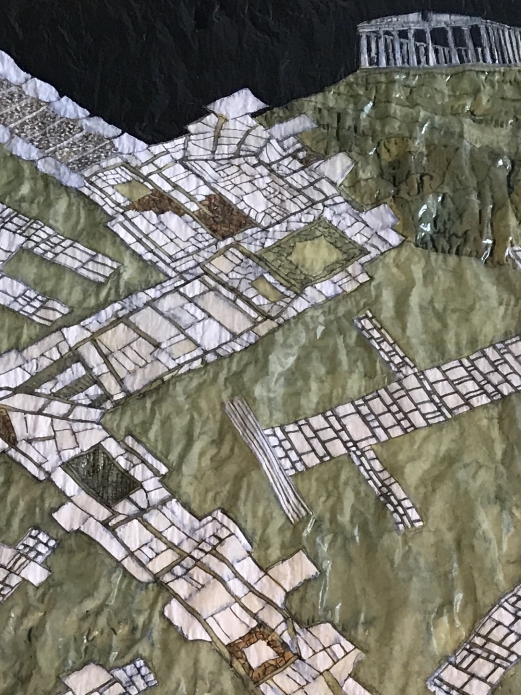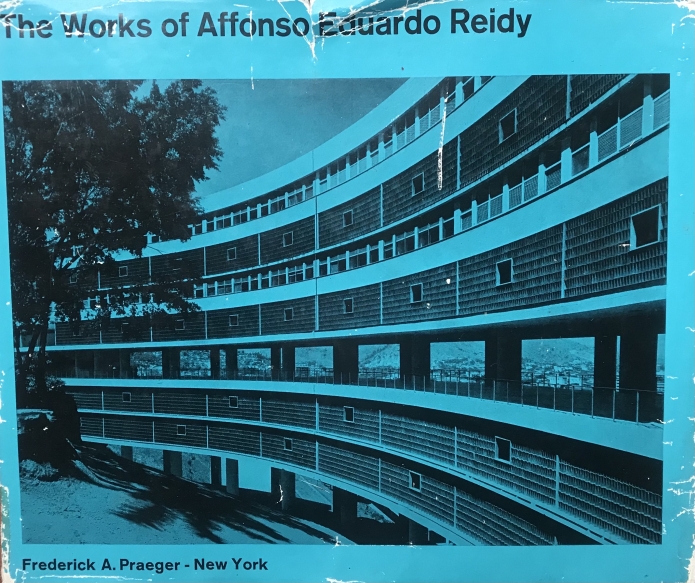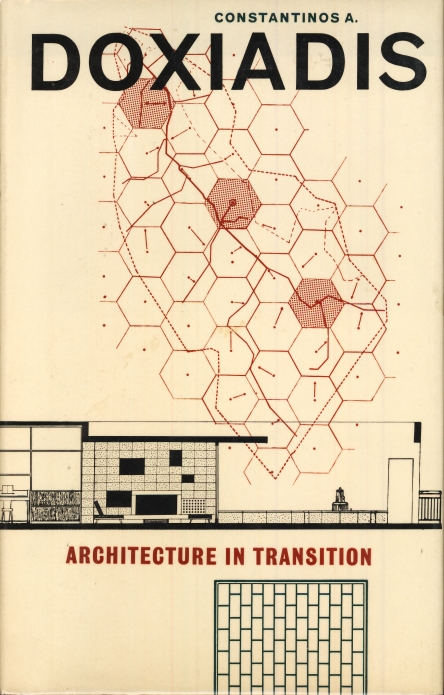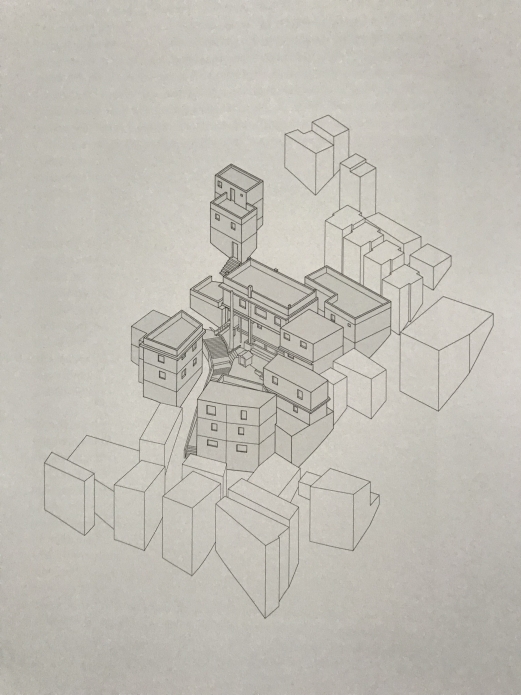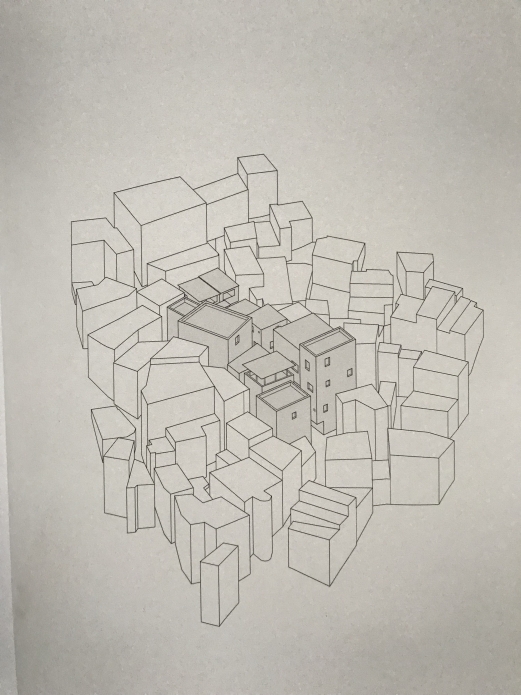La fine del Regionalismo
Alberto Ferlenga
Figg.
a-c - Alberto Ferlenga, disegni dedicati a Dimitris Pikionis, Fernand
Pouillon e Joze Plecnik. Acquerelli e stilografica su carta gialla da
schizzo.
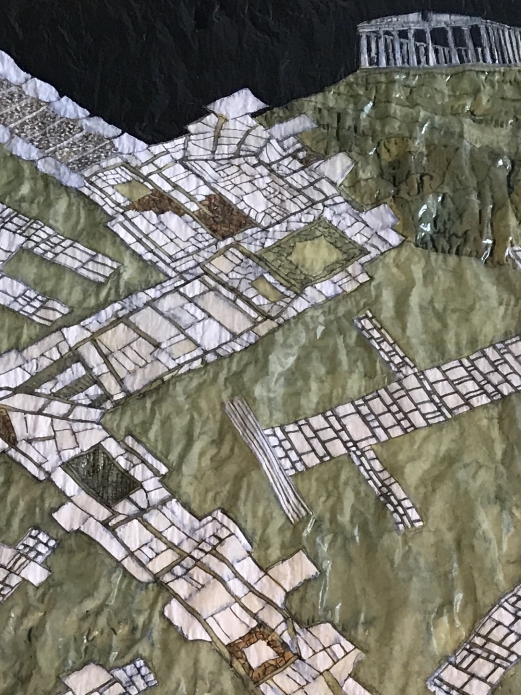


Fig. 4 - Veduta della Scuola Sperimentale ad Assunciòn, Paraguay di A.E. Reidy, 1953.

Fig. 5 - H. Fathy, planimetria della piccola città di New Bariz nell’oasi di El Kharga in Egitto, 1965.

Fig. 6 - Riunione plenaria dei Delos Symposia nel teatro dell’isola di Delos, 1968.

Fig.
7 - D. Pikionis, il padiglione da tè e la chiesa nel complesso
di S. Dimitris Loumbardiaris ad Atene nelle condizioni attuali.

Fig.
8 - D. Pikionis, il padiglione da tè e la chiesa nel complesso
di S. Dimitris Loumbardiaris ad Atene nelle condizioni attuali.

Fig. 9 - F. Pouillon, Climat de France ad Algeri, 1960.

Fig.
10 - Immagini di Venezia durante il lockdown del 2020, foto di U. Ferro
e L. Pilot, da Venezia Vuota, di A. Ferlenga e F. De Maio, 2021.

Fig.
11 - Immagini di Venezia durante il lockdown del 2020, foto di U. Ferro
e L. Pilot, da Venezia Vuota, di A. Ferlenga e F. De Maio, 2021.

Fig. 12 - Barrios Informales nel centro di Lima, foto: A. Ferlenga.

Figg. 13-14 - Rilievi di aggregazioni abitative nelle favelas di Rio de Janeiro, da: Informal rooting di A. Tessari, 2020.
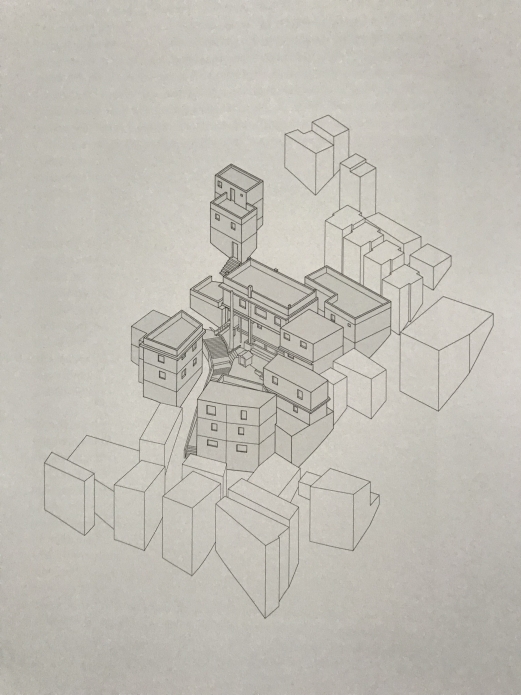
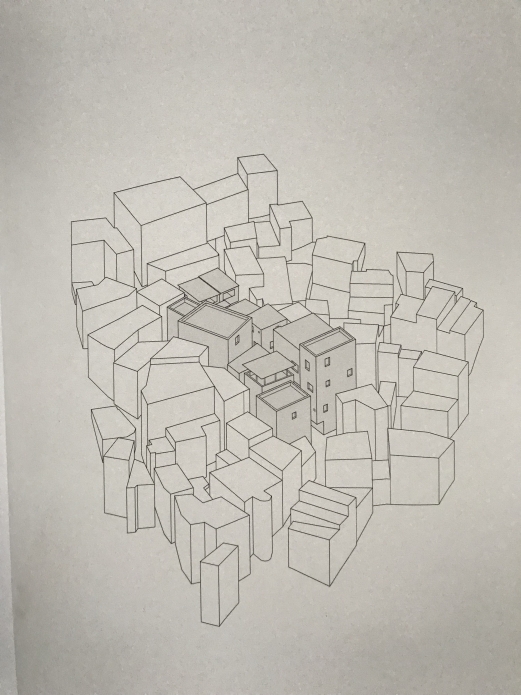
[…] In the last twenty or thirty years, new
directions in contemporary architecture have not come from Europe
alone: A Universal civilization is approaching, and its development
shows no symptoms of international standardization. Its common element
is its conception of space, which is in keeping with both the emotional
structure and the outlook of the period […] There is yet
another factor of equal importance, one that arises from an attitude
shared by the best contemporary architects. These architects aim, above
all, at taking full account of the changeless atmospheric and
topographical conditions of a country, which are no longer obstacles
but springboards for the creative imagination. It has often been
observed that the painting of the present century has repeatedly taken
soundings of the past in order to renew contact with kindred elements
in mankind of earlier times and to derives strength from this contact.
Neither I have elsewhere called this coming to terms with pre-existing
atmospheric and topographical condition a “new
regionalism” […] Within this common concept of
space, many different forms of architecture are developing, leading to
unexpected situations.
(fig.a,b,c)
Così scriveva nel 1960 Sigfried Giedion
introducendo The Works of Affonso Eduardo Reidy
di Klaus Frank (1960), (fig. 1) la prima monografia sul lavoro
dell’architetto brasiliano autore, tra l’altro, del
Museo d’Arte moderna di Rio de Janeiro e della Scuola
Sperimentale di Assunciòn in Paraguay. (fig. 2) Giedion
riprende nel testo alcune idee maturate già a partire dagli
anni ‘40 all’interno dei CIAM che lo vedranno
progressivamente distaccarsi dalle interpretazioni più
dogmatiche del Movimento Moderno per aderire alla nuova visione di una
architettura attenta al rapporto con l’ambiente e con la
storia e ai temi della sostenibilità urbana e della misura
umana. Temi che in quegli anni incominciavano ad emergere dalla crisi
dei CIAM e nelle teorizzazioni di architetti noti come Richard Neutra o
Aldo Van Eyck e che, in forma più compiuta, costituivano il
filo conduttore del lavoro dall’architetto greco Constantinos
Doxiadis (fig. 3), planner di fama
internazionale, e tecnico di punta dell’establishment
democratico statunitense e delle Nazioni Unite sui fronti urbanistici
della guerra fredda. Doxiadis, antico discepolo di Dimitris Pikionis
presso il Politecnico di Atene, è stato, tra
l’altro, il propugnatore di una scienza, l’Ekistica,
basata sul rapporto tra architettura e insediamenti che, tra molte
forzature e ambiguità, ha avuto il pregio di anticipare i
temi dell’attuale sostenibilità. Ne erano premessa
le analisi sulla nuova crescita delle città, esposte da Jean
Gottmann nel suo Megalopolis (1961) ma anche i
drammatici problemi insediativi seguiti alla Partition
tra India e Pakistan (1947) e, ancor prima, alla Katastrophé
dei Greci in Asia Minore (1923). Introdotto alla conoscenza di Doxiadis
da Jaqueline Tyrwhitt, urbanista inglese e fervente seguace di Geddes e
delle sue teorie ma anche membro attivo del CIAM, Giedion
percorrerà un pezzo importante di strada con
l’osservatorio “ekistico”
che in Atene coniugava le tematiche globali e localistiche con una
tradizione insediativa antica già studiata da Doxiadis nella
sua tesi di dottorato Architectural Space in Ancient Greece
(fig. 4) discussa nel 1936 a Berlino e divulgata in inglese dalla
Tyrwhitt nel 1972. La tesi riprendeva le considerazioni sulla
composizione dinamica dei monumenti dell’Acropoli avanzate da
Auguste Choisy nella sua Histoire de l’Architecture
(1899), nel capitolo dedicato al Pittoresco Greco – le cui
immagini erano state utilizzate, come si sa, anche da Le Corbusier in Vers
une architecture (1923), e le considerazioni di Pikionis
sulla costruzione dello spazio sacrale greco attraverso sistemi
geometrico visuali. Doxiadis ampliava, però,
l’osservazione dall’Acropoli ad altri casi di
recinti sacri e città greche e sottintendeva, con tutta
evidenza, la possibilità di riutilizzo di alcuni principi
insediativi antichi anche nel mondo presente per reiterare una
relazione dinamica tra spazio pubblico e architettura e migliorare la
qualità della vita urbana. Del gruppo “ekistico”
arriveranno a far parte, oltre a Gottmann, storici come Arnold Toynbee,
Margaret Mead, scienziati come Jonas Salk, paesaggisti come Lawrence
Halprin oltre a ingegneri come Bukminster Fuller e architetti come
Fumihiko Maki o Hassan Fathy (fig. 5) e alle sperimentazioni egiziane e
irachene di quest’ultimo su materiali e clima Giedion si
riferisce esplicitamente in un altro passo dell’introduzione
a Reidy.
Le idee di una architettura legata all’ambiente, di
città-mondo e allo stesso tempo
“demoltiplicate” nel loro corpo vivo grazie a
centralità minori e diffuse, rispettose della misura umana,
le nuove forme dell’abitare, l’attenzione a fattori
climatici, alla viabilità, ai temi ambientali in generale,
vengono approfonditamente discusse tra il 1963 e il 1975 nei Delos
Symposia, (fig. 6) eventi spesso citati ma ancora oggi poco
studiati, che si rifacevano apertamente, nella ritualità, ai
viaggi e ai convegni dei CIAM, rispetto ai quali Tyrwhitt e Giedion
assicuravano una sorta di continuità ideale, ma ne
ampliavano e diversificavano la partecipazione, rivolgendo forse per la
prima volta l’attenzione di un’ampia rappresentanza
della cultura del tempo ai nuovi aspetti di un mondo urbano che stava
mutando i suo parametri di riferimento.
Giedion, percepisce i cambiamenti che l’architettura
inizia a manifestare in un’epoca in cui la spinta delle
avanguardie perde forza di fronte alle nuove emergenze sociali ed
economiche e ad uno sviluppo della comunicazione che muta radicalmente
lo scambio e la conoscenza delle idee in ambito sociale ma anche
urbano. Aveva lavorato su questi temi in Canada, tra il 1951 e il 1957
nell’Exploration Group, insieme a
McLuhan e alla stessa Tyrwhitt, ed elaborerà la definizione
di Nuovo Regionalismo proprio per descrivere una
attitudine nascente in architettura attribuendo, dunque, a questo
termine un’accezione positiva. Malgrado ciò, dalle
sue considerazioni trapela ancora l’ambigua differenza tra un
mainstream ancora legato all’influenza
dei CIAM e delle avanguardie ed un’architettura nuova ma
ritenuta ancora secondaria per localizzazione geografica ed espressione
formale, anche se capace di intuire e declinare le nuove esigenze del
mondo. Un’architettura fatta di esperienze locali,
coinvolgimenti politici spesso discutibili e comunque molteplici,
rapporti stretti con le città esistenti, linguaggi
diversificati, rapporti complessi con le tecnologie.
Un’architettura non riconducibile a stili, scuole o movimenti
ma che trova piuttosto il suo tratto comune nel rapporto con quella che
Pikionis chiamava l’«unica tradizione
dell’Architettura del mondo» (fig. 7, 8) declinata
in mille versioni ma sostanzialmente unitaria nei principi. Ed
è proprio il riconoscimento di protagonisti
“anomali” come Reidy da parte di attenti ma
“condizionati” osservatori come Giedion a mettere
in luce, paradossalmente, la grande opera di rimozione perpetrata dalla
cultura architettonica più avanzata nei confronti di una
vicenda novecentesca spesso parallela a quella più
conosciuta ma considerata superata e poco significativa.
Manuel de Solà Morales in un saggio del 1987
pubblicato in Spagna su «UR, urbanismo revista»,
e pochi anni dopo in Italia su «Lotus
International» (1989), dal titolo Otra
Tradiciòn Moderna è stato tra i primi
a cercare di delimitare dentro la storia del Novecento i contorni di
questa nuova tradizione per molti versi anticipatrice, specie per
quanto riguarda il contesto urbano.
In Olanda l’opera ben nota de Willem Dudok e di J.J.
Oud tanto quanto la più classica di Michel de Klerk o di
Hendrik Petrus Berlage, mostra uno stile nel progetto urbano che la
situa come intromissione dentro un contesto stabilito. I lavori di
Giuseppe de Finetti, Emilio Lancia, o di Giovanni Muzio a Milano,
quelli di Kay Fisker, Carl Petersen o Ivar Bentsen a Copenhaghen,
quelli di di Eliel Saarinen a Helsinky e Sven Markelius a Stoccolma,
quelli di Joze Plecnik a Lubiana come quelli di Francesc Folguera in
Catalunya o di Secondino Zuazo a Madrid manipolano la città
come campo della nuova architettura senza che essa perda mai il suo
ruolo come strumento di ordinamento urbano, Saggia disciplina che parte
in verità dall’amore e non dall’odio nei
confronti della città esistente e che per questo rende la
sua trasformazione più rigorosa […] Era un
urbanistica che si misurava con la condizione distinta di ogni parte
urbana, con l’idea della città come artefatto
complesso sempre più ricco e diversificato. Credo che qui,
in questa complessità si debba riconoscere la vera
tradizione della città moderna. (Solà Morales
1989) (fig. 9)
Il punto di vista di Manuel de Solà Morales
è prevalentemente rivolto alla città ma se
ampliassimo il discorso ad altri temi che oggi hanno assunto una nuova
rilevanza come quelli ambientali o identitari le vicende di quel secolo
– scritti e progetti – ci offrirebbero in gran
numero riflessioni analoghe in quanto a preveggenza e
utilità.
Si tratta di “sperimentazioni” meno
appariscenti e più realistiche di quelle della
modernità conclamata, declinate in espressioni formali
spesso ostiche, non sempre in grado di lasciare edifici iconici, ma
capaci di produrre frammenti urbani riconoscibili e indagini su vari
aspetti dell’architettura tradizionale e delle
città: da Amsterdam a Lubiana, da Amburgo ad Atene, dalla
Svezia alla Spagna. Esse ci consegnano un quadro di riflessioni e di
realizzazioni che, depurato da ingombranti zavorre ideologiche e da
sistemazioni critiche strumentali, si dimostra, sempre di
più, sterminato e fertile. Della sua esistenza si accorge,
qualche anno dopo Giedion, Kenneth Frampton che nell’ansia di
etichettare il fenomeno, e di distinguerlo da altri finisce,
però, con il replicare lo stesso errore dello storico
tedesco. Come era già accaduto per Giedion, ma con
l’aggravante di una situazione storicamente più
chiara, infatti, l’interesse di Frampton nei confronti delle
declinazioni meno convenzionali dell’architettura del secolo
scorso, sintetizzate nella definizione di Regionalismo
Critico, non può sfuggire al carattere
intrinsecamente limitativo della sua stessa denominazione finendo con
l’individuare ghetti eccellenti, vicende irripetibili e, di
fatto, preferenze personali. Così, ancora una volta, una
storia complessa come quella dell’architettura del Novecento
in cui avanguardia e tradizione si intrecciano spesso nelle
realizzazioni dei medesimi protagonisti e le idee passano attraverso
relazioni personali che travalicavano le posizioni “di
facciata”, viene ridotta ad evento di secondo piano e ad una
vetrina di personaggi isolati, importante da ricordare, in attesa di
una vera ondata innovatrice.
Scrive Frampton:
Il Regionalismo critico presuppone necessariamente un rapporto
più esplicitamente didattico con la natura di quello
definito dalle tradizioni astratte e formali
dell’architettura dell’avanguardia. (Frampton 1984)
ma è corretto attribuire a quel campo
architetti come Plecnik, Pouillon (fig. 10) o Pikionis in Europa o
Reidy e Vilanova Artigas in Brasile, tanto per citare alcuni esempi?
Non dovremmo, invece, considerare i loro contributi componenti
essenziali di una modernità in architettura che sarebbe ora
di considerare come una vicenda unica, sfaccettata e complessa,
piuttosto che un catalogo di false coerenze o somma di drastiche
opposizioni?
Se partiamo da questo punto di vista, lo spazio di un secolo i
cui effetti non sono ancora finiti, ci appare come una miniera ancora
in gran parte da sfruttare.
E sempre partendo da questo punto di vista, dovremmo rilevare
come l’attenzione ai luoghi e alle identità sia
sempre stata una costante in tutta la storia del ‘900
architettonico anche quando le spinte palingenetiche e gli intenti
futuristici sembravano oscurare tutto il resto. Ciò che
è cambiata nel tempo è piuttosto la
considerazione dell’importanza di questa ricerca, la sua
utilità rispetto ai temi odierni. Una consapevolezza che
cresce di pari passo con la difficoltà di riconoscere
ciò che il mondo contemporaneo ha generato in quanto ad
aspetto fisico nelle città e nell’ambiente e con
il fallimento degli strumenti di progetto o di controllo a larga scala
e, per contro, delle ricette liberistiche. La compresenza di fenomeni
di globalizzazione e di differenze locali è oggi un fatto
consolidato e spesso nelle seconde è contenuta una ricchezza
formale e una capacità di reazione ai problemi del nostro
mondo maggiori che nei primi. D’altra parte, la cornice
dentro cui ci muoviamo non è più quella del
progresso economico e delle ideologie totalizzanti, ma piuttosto quella
della transizione e dell’incertezza dentro la grande crisi
ambientale, sociale e urbana. Un quadro, questo, che altri hanno
intuito come priorità di una nuova epoca se consideriamo, ad
esempio, intellettuali anomali come Oswald Spengler, Patrick Geddes,
Lewis Mumford, Jean Gottmann e lo stesso Doxiadis. Portatori di una
cultura le cui intuizioni rispetto al futuro sono apparse molto
più vicine alla realtà di quelle prefigurate dai
salti in avanti delle cosiddette avanguardie: un nuovo
realismo piuttosto che un nuovo regionalismo.
Ma indicare un terreno di studio dentro una storia dimenticata
non basta più. Le nuove emergenze non richiedono solo il
recupero di idee anticipatrici ma nate dentro condizioni superate dai
fatti, bensì la ricostruzione di forme di conoscenza e di
strumenti pratici e teorici che nel loro insieme configurino una
cultura “laica” e adatta ad affrontare il tempo
presente e le sue contraddizioni.
Dentro la storia dinamica e fatta di continui ritorni delle
città questo vuol dire, ad esempio, riprendere il filo di
una lettura analitica, ravvicinata, dei fenomeni in corso per quanto
riguarda gli aspetti formali di un mondo come quello urbano in cui i
tempi si confondono continuamente dando una connotazione molto speciale
all’idea di attualità. Una lettura del mondo,
delle sue città, dei suoi paesaggi, interrotta almeno 50
anni fa e che ha avuto in Italia uno dei suoi luoghi
d’origine e di maggior sviluppo. Ciò implica anche
il tornare a considerare il valore esemplare di alcune aree che, come
l’Italia, si presentano come veri e propri archivi viventi
dei valori urbano-architettonici. Ogni città italiana ha un
suo carattere, plasmato dalla storia, una sua identità che
non può essere certo replicata, ma possono esserlo le sue
dimensioni, la misura dei suoi spazi pubblici, il suo rapporto con la
topografia o il paesaggio, il suo stare dentro organizzazioni
metropolitane o naturali più ampie, la sua
capacità di produrre uno speciale benessere di vita e di
lavoro. In un momento particolare e tragico come è stata
questa pandemia una città come Venezia, (fig. 11, 12) ad
esempio, l’ha ampiamente dimostrato. Ma non è solo
la storia a insegnarci ancora qualcosa. La necessità
dell’identità emerge anche in luoghi –
sempre più diffusi nel mondo – in cui la vita
è segnata dalla temporaneità e dalla
disperazione. Suketu Metha nel suo La vita segreta delle
città (2016) dedicato a Italo Calvino, dieci anni
dopo Maximum City ritorna su questo tema
rileggendo gli slum di Mumbay dove gli abitanti,
pur nella precarietà di un abitare ai limiti della
sopportabilità umana, ricostruiscono forme disperate di
identità nominando rivoli fognari o cumuli di immondizie con
i nomi dei fiumi e delle colline dei loro villaggi lontani e cercando
di riprodurne gli spazi architettonici e pubblici. La stessa cosa
potremmo dire considerando l’evoluzione delle favelas
di Rio de Janeiro o dei barrios informales (fig.
13) di Lima dove gli spazi e le architetture si riaggregano per
generare un valore evocativo e sociale che, inevitabilmente e
inconsapevolmente, riprende la memoria delle città, e le
infrastrutture (funicolari, scale, ecc.) si tramutano in altrettante
occasioni per segnare nuove identità.
Tornano dunque gli stessi temi, nelle città, ma le
condizioni e le dimensioni in cui si presentano e la nostra stessa
mutata sensibilità nei confronti dell’ambiente
richiedono una riconsiderazione complessiva di storie, teorie e
strumenti e una nuova conoscenza delle condizioni contemporanee del
vivere urbano (fig. 14, 15), grazie alla quale rintracciare i materiali
e gli strumenti che possano dar vita a processi virtuosi di
trasformazione e di riconoscimento che interessino le parti
più abitate del mondo e non i pochi metri quadrati delle
– indistinguibili tra loro – Downtown
metropolitane.
Bibliografia
CHOISY A. (1899) – Histoire de
l’Architecture. Gauthier-Villars, París.
DOXIADIS C. (1972) – Architectural Space
in Ancient Greece. MIT Press, Cambridge.
FRAMPTON K. (1984) – “Anti tabula rasa:
verso un Regionalismo critico”. Casabella 500, marzo, 22-25.
FRANCK K. (1960) – The Works of Affonso
Eduardo Reidy. Frederick A. Praeger, New York.
GOTTMANN J. (1961) – Megalopolis the
Urbanized Northeastern Seaboard of the United States. MIT
Press, Cambridge.
LE CORBUSIER (1923) – Vers Une
Architecture. Éditions Crès,
París.
METHA S. (2016) – La vita segreta delle
città. Einaudi, Torino.
SOLÀ MORALES M. (1989) – Un’altra
tradizione moderna. Lotus International, 64.
SOLÀ MORALES M. (2021) – Miradas
sobre la ciudad. Acantilado, Barcelona.
TESSARI A. (2020) – Informal Rooting. An
Open Atlas. LISt Lab.